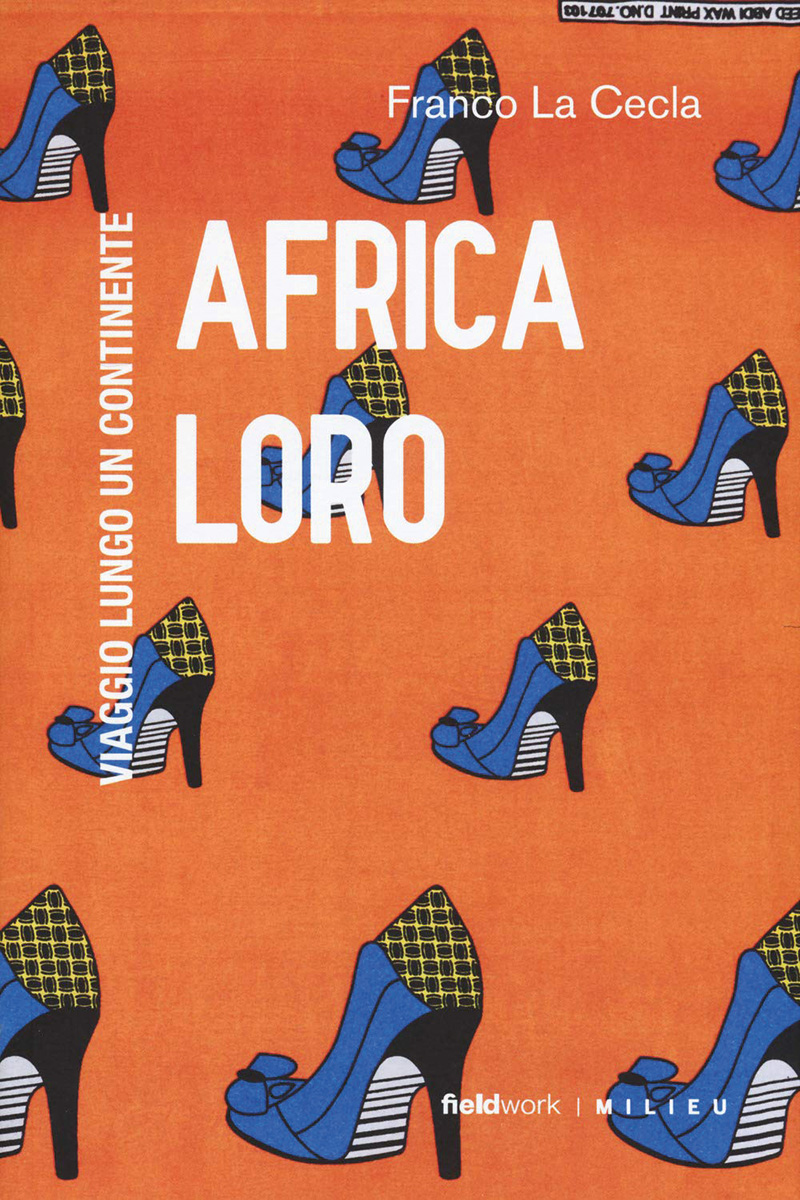Riflessioni sull’Africa
Un antropologo e tre architetti si riuniscono tramite l'Accademia di Mendrisio per riflettere con gli studenti sulla concezione dell'urbano in Africa.
«Oggi l’Africa si avvia come non mai prima verso l’urbanizzazione. Il 40% degli africani, più di 400 milioni di persone, vive in un’area urbana e si dice che nel 2025 si tratterà del 50%, con una proiezione di più di un miliardo di cittadini. Un incremento meno forte che in Asia o in America Latina, ma comunque una tendenza forte. Un quarto delle città con il più rapido incremento di popolazione stanno in Africa, che ospita cinquantadue città con più di un milione di abitanti e megacities come il Cairo (8 milioni), Lagos (5,5), Kinshasa (10), seguite da altre grandi conurbazioni come Johannesburg, Nairobi, Dar Es Salaam, Luanda, Khartoum e Abidjan.
Se queste sono le cifre però da sole raccontano ancora poco del modo africano di essere città e delle dinamiche che vi sottostanno. L’inurbamento, come in altre aree del mondo, è dovuto alle condizioni critiche delle aree rurali, alla diffusione di monoculture che cacciano via i piccoli agricoltori, al land grabbing operato dalle grandi imprese cinesi, israeliane, alla siccità e ai cambiamenti climatici. Vi sono altre cause, guerre, la minaccia di Isis nelle aree rurali, e anche ovviamente l’attrazione che le città esercitano come luogo di occasioni e di arricchimento. L’effetto sono grandi slum, immense aree di baracche, il concentrarsi alla periferia ma anche nel centro della città di una popolazione che spesso si raggruppa per aree ed etnie di origine. Ci sono città come Nairobi che ha circa 5 milioni di abitanti che concentrano tutti gli squilibri del continente, tra gated communities per impiegati delle Nazioni Unite e bidonvilles, tra parchi e shopping centers.
Si può dire che le città africane sono un lascito della colonizzazione? In realtà questo è vero per alcune aree del continente e meno per altre. C’erano città africane prima del colonialismo, soprattutto in Africa occidentale, le città dei regni del Ghana e finitime. E se è vero che per gli europei la città rappresentava un rifugio sicuro dai timori della brousse e della savana, dopo l’indipendenza esse sono state risignificate dalle classi politiche locali. E oggi hanno un’identità africana indubitabile. E una grande vitalità che si esprime in traffico caotico, commercio di strada, ma anche produzione di culture urbane, moda, musica, arte. L’Afro-modern è un fenomeno esteso e interessantissimo che ingloba buona parte dell’Africa subsahariana ed esprime l’incredibile giovinezza del continente, l’unico che abbia una così grande quantità di giovani. Ne è testimonianza una rivista geniale, pubblicata tra Lagos e Cape Town, Nataal, che raggruppa tutte le avanguardie che stanno nascendo nel continente.
Questa impressione di frammentazione, di città fatta di frange e di macchie di leopardo la si prova anche altrove, in Mozambico, in Etiopia e pure lo stesso sollievo di campagne che resistono in città, di luoghi ameni che reggono nonostante i centri. Sembra che le città effettivamente esistano solo per giustificare una centralità che poi viene subito contraddetta dai flussi e dai movimenti reali della gente. L’Africa subsahariana è un’area di enorme mobilità. Che è per altro una delle tradizioni del continente, il nomadismo, lo spostarsi senza tener alcun conto dei confini tracciati dal colonialismo. Una ricerca condotta sulle mukeristas, le «frontaliere» che commerciano tra Maputo e Johannesburg lo descrive molto bene. Un traffico di settantamila donne frontaliere; mukeristas viene da un misto di bantu, inglese e portoghese, significa: may you carry this bag to the other side? Una giovane ricercatrice italiana, Paola Piscitelli, ha passato molto tempo nei pulmini delle mukeristas, testimoniando la porosità dei confini tra Mozambico e Sudafrica. È una realtà presente dappertutto nel continente. Un’idea di cittadinanza mobile, che approda a una pratica di "trans-nazionalità" e pluri-appartenenza. Le identità di molti popoli africani sono da sempre state mobili e solo il colonialismo ha cercato di fissarle, per altro non riuscendoci. Oggi le città africane sono diverse dalle altre città del mondo perché per capirle occorrerebbe mapparle in modo diverso. Sono più che altro centri di aggregazione intorno a mercati, polipi che si sfilacciano per lasciare combinare flussi. C’è chi parla di globalizzazione dal basso, io piuttosto direi che qui la gente ha inventato un modo di resistere e di servirsi di una contro-globalizzazione che è fedele a una tradizione di nomadismo e mobilità».
Guarda qui il video del seminario InAfrica. Pensare, conoscere, fare l’Africa
Il lungo paragrafo di apertura dell’antropologo Franco La Cecla, invitato dall’Accademia di architettura di Mendrisio al seminario del primo anno dal titolo InAfrica. Pensare, conoscere, fare l’Africa (inizialmente previsto per il 31 marzo e poi tenutosi online; è possibile vederlo qui), anticipa alcuni dei diversi argomenti affrontati in questa giornata. L’incontro, programmato con l’obiettivo di sensibilizzare e aiutare gli studenti a meglio comprendere alcuni aspetti dell’operare nel continente africano, è stato sicuramente stimolante per i futuri architetti che si confrontano con le prime esperienze progettuali e prevede un approccio teorico introduttivo che dà poi spazio a esperienze reali condotte sul campo.
Le riflessioni dell’antropologo su Il modo africano delle città si concentrano sulle megalopoli del continente viste da un bianco europeo e lo mettono a confronto con quanto sappiamo oggi di città e territorio. La Cecla è infatti l’autore di Africa loro. Viaggio lungo un continente (Milieu edizioni, Milano 2019), testo che riunisce le impressioni vissute in prima persona e raccolte in un diario da «novellino», dove afferma: «per capire le città africane occorre visitarle, passarci del tempo e accorgersi che c’è qualcosa di specificamente africano nel loro modo di essere».
Il seminario ha proposto inoltre le esperienze di tre architetti che lavorano in Africa – Gaetano Berni, Luca Astorri e Alberto Pottenghi – tese ad illustrare le loro testimonianze dirette attraverso differenti approcci.
Gaetano Berni opera per l’ong Liveinslums ed è coinvolto in Inside Mathare, un progetto di riscatto sociale della comunità di Mathare – quartiere marginale di Nairobi, secondo per grandezza nella capitale del Kenya – che ospita una popolazione di circa 500'000 abitanti e occupa all’incirca 1,5 chilometri quadrati. Il leader comunitario è Dominic Otieno, un insegnante di calcio da sempre votato a prendersi cura dei bambini più bisognosi, con il sogno di creare una scuola che possa contrastare il grave fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile, garantendo loro un futuro migliore. Nel 2012 Otieno riesce ad acquistare il terreno che oggi occupa la Why Not Junior Academy. Gli interventi sull’area sono stati puntuali e divisi in fasi progressive (cucina; orto; primo piano; secondo piano; campo da basket; centro civico). Tutte le lavorazioni sono state fatte coinvolgendo in modo diretto i membri comunitari con il supporto di tecnici italiani. I materiali utilizzati per la costruzione sono stati reperiti in aree limitrofe: struttura portante in legno, facciate del piano terra in terra cruda mentre i serramenti e le facciate del primo piano sono in bambù. Negli anni questa comunità si è rafforzata e sono nate molte attività extrascolastiche e sportive che rendono la WNJA un punto di riferimento e un luogo di identità per la comunità di Mathare.
La consegna di Luca Astorri di «fare come etica» si lega al concetto del Learning by doing. «Lo scopo e la sfida che ci siamo posti come architetti con il programma in loco, tramite il quale negli ultimi due anni trenta ragazzi disoccupati, provenienti dal mondo delle costruzioni, hanno avuto la possibilità di realizzare ciò che loro stessi hanno progettato, attraverso un processo di partecipazione attiva con le diverse comunità in cui siamo intervenuti, contribuendo non solo a migliorare e sviluppare infrastrutture ma anche a costruire una rete di giovani professionisti in un continente dove il tasso di disoccupazione giovanile sfiora il 30%. Fare come atto conoscitivo, di condivisione. Fare come momento formativo, che assume significato di attività sociale all’interno di un gruppo o di una comunità. Fare come processo di crescita individuale e allo stesso tempo collettivo. Il progetto e l’architettura diventano gli strumenti attraverso i quali è possibile creare oltre a un luogo anche una comunità. Il cantiere diventa terreno di apprendimento e formazione, una scuola a cielo aperto, una piazza dove si incontrano pensiero e azione, dove la condivisione risiede nel processo. Così il costruire assume un significato diverso dal mero sforzo fisico, diventando momento di apprendimento, e di presa di coscienza tramite l’atto stesso del fare: learning by doing».
Alberto Pottenghi, infine, che in qualità di collaboratore di Kéré aveva già contribuito alla rubrica AAM dedicata all’accoglienza e alla cooperazione, assistente dell’atelier dell’architetto Diébédo Francis Kéré a Mendrisio, è ora collaboratore della cattedra dello stesso professore alla facoltà di Architettura della Technische Universität di Monaco. Con diversi anni di esperienza alle spalle propone una riflessione sul tema della Partecipazione radicale per spiegare come «l’atteggiamento partecipativo nei confronti del processo di progettazione, oltre a contribuire a creare un progetto che risponde ai bisogni reali, sviluppa un senso di appartenenza e responsabilità e garantisce che la nuova opera sia accolta e rispettata».
In questo caso emerge come nei villaggi rurali africani gli anziani, per tradizione, discutono e definiscono le attività in comune. Gli altri membri possono osservare, tutti i componenti hanno un proprio ruolo e tutti sono chiamati a dare il loro contributo. Questa attitudine, oltre a generare nuove competenze e conoscenze in diversi campi, promuove nei partecipanti maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente e dell’uso del suolo. Forse una lezione anche per noi.
«Archi» 2/2020 può essere acquistato qui. Qui puoi invece leggere l'editoriale con l'indice del numero.