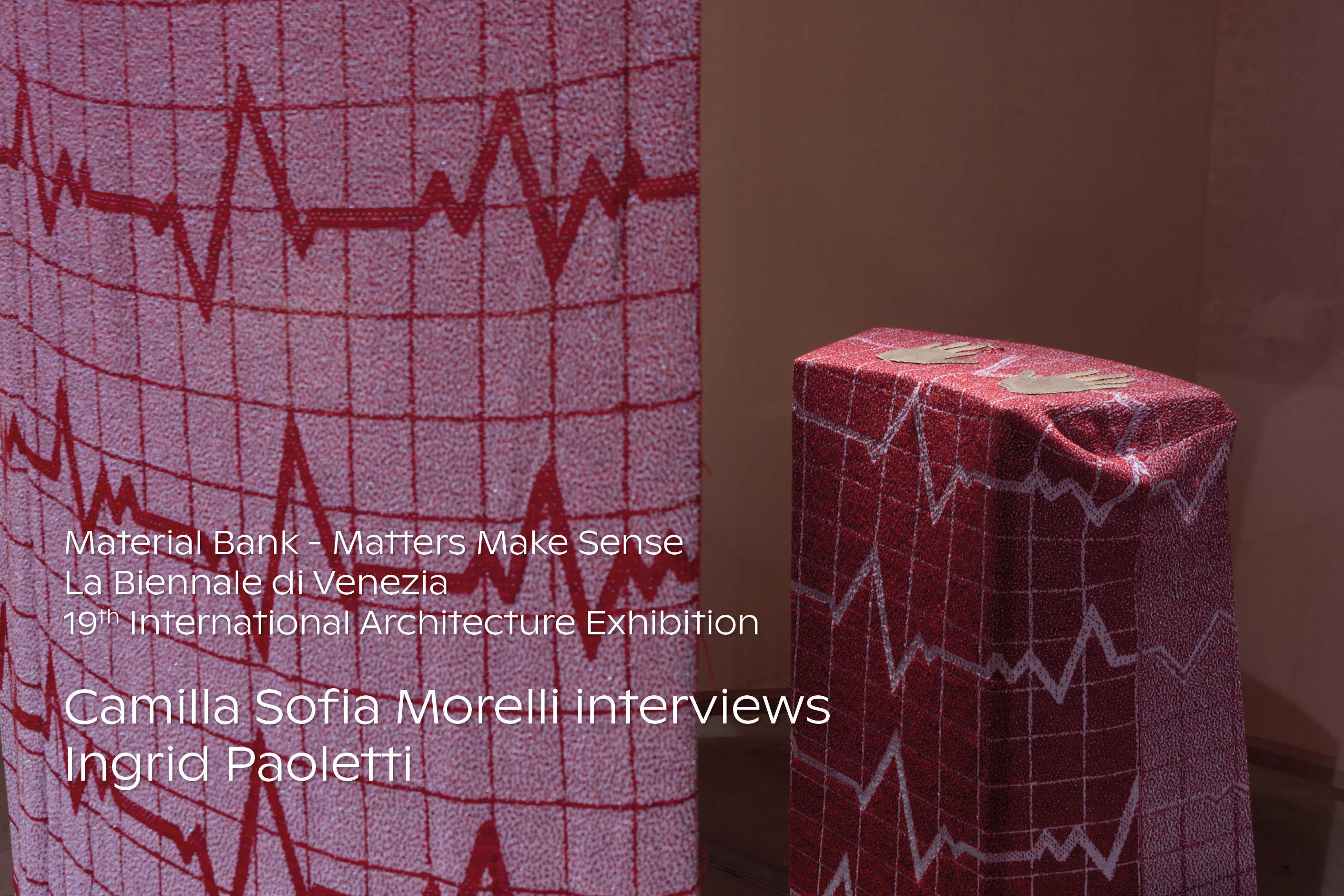«La luce naturale è fondamentale»
Intervista a Annette Gigon
Il Daylight Award premia la ricerca e l'utilizzo della luce naturale. Perché questo premio è importante? Annette Gigon, vincitrice del premio e membro della giuria, parla del ruolo multiforme della luce nell'architettura.
Annette Gigon, lei è vincitrice del premio 2012 e già per la seconda volta membro della giuria del Daylight Award. Qual è l'importanza della luce naturale nella sua architettura?
La luce del sole è essenziale, ci collega al cosmo ed è uno dei presupposti per la vita sulla Terra. Naturalmente deve essere presente anche nei nostri edifici. Allo stesso tempo, uno dei compiti dell'architettura è sempre stato quello di proteggere dalle forze della natura, compresa l'eccessiva luce solare.
Per questo motivo l'architettura non può essere né completamente chiusa né completamente aperta. Deve dosare e filtrare, creando un equilibrio intelligente tra ciò di cui l'uomo ha bisogno e ciò che è eccessivo. Mi piace l'idea che l'architettura, che è fisica e opera con materiali solidi e pesanti, si «increspi», sia porosa o addirittura spaziosa, in modo che gli elementi leggeri e immateriali come la luce e l'aria possano penetrarvi e soffiarvi dentro: l'architettura come interazione tra la crosta terrestre e l'atmosfera.
La sua architettura opera con il contrasto di luce e ombra, che evidenzia plasticamente i corpi edilizi e le loro articolazioni. Ma lei ama anche la rifrazione della luce, che produce l'effetto opposto: i volumi brillano, le superfici si sfumano, i contorni si confondono. Gli edifici perdono parte della loro pesantezza fisica e la luce diventa visibile, quasi come un materiale da costruzione immateriale che assume corpo. Ne sono esempi il Museo Kirchner a Davos, ma anche progetti più recenti come l'edificio per uffici sulla Lagerstrasse o la Andreasturm a Zurigo.
Anche questo ha a che fare con il dosaggio della luce. In questo intervallo tra troppo e troppo poco risiede una libertà architettonica che rende il nostro lavoro di progettisti così entusiasmante. Gli edifici odierni devono soddisfare requisiti di comfort sempre più elevati e rispettare sempre più normative, in particolare per quanto riguarda il loro consumo energetico durante il funzionamento. Per questo motivo dobbiamo pensarli in più strati.
Trasformare questa costrizione costruttiva in un compito creativo – utilizzare strati di materiali più o meno opachi per poi operare con la loro opacità, traslucenza, trasparenza, riflessione, diffusione e colore – è ciò che ci affascina. Consideriamo le diverse barriere funzionali, i filtri e i confini tra interno ed esterno come un tema architettonico sempre nuovo, al quale vogliamo contribuire in qualità di progettisti.
In questa composizione di strati esistono anche conflitti di obiettivi. La riduzione al minimo dei carichi di riscaldamento e raffreddamento, ad esempio, richiede un volume il più compatto possibile, spesso con una grande profondità di costruzione, il che è sfavorevole per l'apporto di luce naturale.
Queste contraddizioni devono essere affrontate. Gli edifici devono garantire un clima interno costantemente piacevole, nonostante le condizioni cambino continuamente nel corso dell'anno e delle ore del giorno, e allo stesso tempo devono essere costruiti in modo da risparmiare risorse e consumare il meno possibile per il funzionamento, il riscaldamento e il raffreddamento.
Per quanto riguarda la luce naturale, un'ulteriore sfida consiste nel portare la luce naturale all'interno dell'edificio, perché è indispensabile per la nostra salute, è disponibile gratuitamente e non consuma energia, evitando però il surriscaldamento e l'abbagliamento, in particolare nei luoghi di lavoro con monitor. Nella maggior parte dei casi ciò è possibile solo in combinazione con la protezione solare e la luce artificiale.
In definitiva, la combinazione degli strati che compongono l'involucro deve consentire un dosaggio preciso, flessibile e sostenibile sotto ogni aspetto di luce, aria ed energia in base alle esigenze specifiche dell'edificio. Il Kirchner Museum o l'ampliamento del Kunst Museum Winterthur sono esempi che rendono particolarmente evidente questa messa a punto: la forma, l'involucro dell'edificio e la costruzione servono a sventagliare, diffondere e distribuire la luce fino a creare all'interno quelle condizioni di illuminazione uniforme e senza ombre di cui hanno bisogno le opere d'arte. Nei musei d'arte si tratta solo dell'1% circa della luce naturale diurna.
Le Corbusier ha scritto: « L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique, des formes assemblées dans la lumière. »
Le Corbusier ha sapientemente guidato la luce all'interno dei suoi edifici, ma qui assume una prospettiva esterna. Naturalmente anche questo ci interessa: come appare un edificio dall'esterno quando la facciata è aperta, chiusa, opaca, traslucida? Come si manifesta la mutevolezza della facciata, necessaria per la vita interna? Questo dipende dalla costruzione dell'involucro.
Proprio il modernismo ha propagato l'apertura e l'orientamento dell'architettura alla luce solare come contrapposizione ai tradizionali metodi di costruzione massicci e all'urbanistica storica, dove le case erano fitte e le finestre ancora piccole. Tra le sue argomentazioni c'era la prevenzione dei danni alla salute dei bambini, che a causa della scarsa esposizione alla luce solare soffrivano di carenza di vitamina D e di rachitismo.
Non voglio però valutare qui né le città antiche né criticare il modernismo, che amo tanto. Il fatto è che il modernismo ha aperto notevolmente le case. Le finestre erano grandi e per lo più ancora a vetro singolo, le costruzioni in nuovi materiali come il cemento armato e l'acciaio erano molto snelle, l'isolamento all'epoca era insufficiente. Questa snellezza o risparmio di materiale è stato compensato con un elevato consumo di energia per il riscaldamento e presto anche per il raffreddamento. I combustibili fossili, il carbone, poi il petrolio e il gas, coprivano il grande fabbisogno energetico.
Ma per completezza va detto che anche gli edifici tradizionali e massicci dopo la seconda guerra mondiale sono stati gradualmente dotati di riscaldamento centralizzato: da quel momento in poi non sono più state riscaldate solo singole stanze per poche ore con piccole stufe, ma tutte le stanze per 24 ore al giorno. Quasi tutte le case sono diventate dei divoratori di energia. Conosciamo le conseguenze.
Quali sono i temi che oggi sono particolarmente importanti per lei nel suo ruolo di giurata del Daylight Award?
Il ruolo multiforme della luce diurna per il funzionamento degli ecosistemi – e in particolare per la salute e il benessere delle persone – non è ancora stato studiato a fondo, ma la scienza ha da tempo dimostrato una cosa: è assolutamente fondamentale. È quindi chiaro che dobbiamo affrontare il tema della luce diurna nella nostra pianificazione urbanistica e architettonica. L'ambivalenza tra troppo e troppo poco, di cui ho parlato, è interessante e stimolante, ma vedo anche un altro tema importante: la luce diurna come fonte di energia.
L'utilizzo della luce solare può contribuire a rendere i nostri edifici più sostenibili, più rispettosi del clima e più efficienti dal punto di vista delle risorse. Ciò significa che almeno il loro funzionamento deve essere a basse emissioni di CO2. Dobbiamo quindi utilizzare mezzi tecnici come il fotovoltaico o il solare termico per produrre energia, in combinazione con un buon isolamento e pompe di calore. Insieme, questi elementi rappresentano l'approccio migliore al moto perpetuo. Questo può sembrare un approccio poco affascinante e poco eroico dal punto di vista progettuale, ma l'architettura può e deve dare un contributo significativo alla riduzione del riscaldamento globale.
Dobbiamo anche essere in grado di integrare nei nostri edifici la tecnologia di cui abbiamo bisogno per soddisfare in modo sostenibile il nostro enorme e sempre crescente fabbisogno energetico. Ciò solleva diverse questioni, anche dal punto di vista progettuale: come possiamo considerare gli impianti tecnici come il fotovoltaico come parte integrante della nostra creazione architettonica, ovvero come veri e propri materiali da costruzione e strumenti di progettazione? È possibile farlo senza ricorrere a colorazioni e strati decorativi inefficienti? Può diventare una pratica comune?
Il Daylight Award può dare un contributo significativo alla ricerca di risposte valide a queste domande.
Il Daylight Award premia contributi eccezionali alla ricerca sulla luce naturale e alla luce naturale in architettura. La giuria del Daylight Award riunisce rinomati esperti del mondo scientifico e dell'architettura: thedaylightaward.com/the-jury/ A partire dal 2026, la Daylight Academy (DLA) lo assegnerà in due categorie: Ricerca (luce naturale e sua importanza per il benessere e per ecosistemi equilibrati) e Architettura (utilizzo artistico e strutturale di alta qualità della luce naturale). Oltre alla fama e all'onore, le persone o i team premiati riceveranno un premio in denaro di 100.000 euro.
Cercasi opere eccezionali – candidate le vostre!
Per il premio 2026, singoli individui, organizzazioni, ricercatori, architetti e professionisti con competenze specifiche possono presentare le loro candidature fino al 15 settembre 2025. Non sono ammesse autocandidature. Inviate le vostre candidature via e-mail a office [at] daylight.academy (office[at]daylight[dot]academy) o compilate il modulo di candidatura. Tutti i dettagli sono disponibili qui.