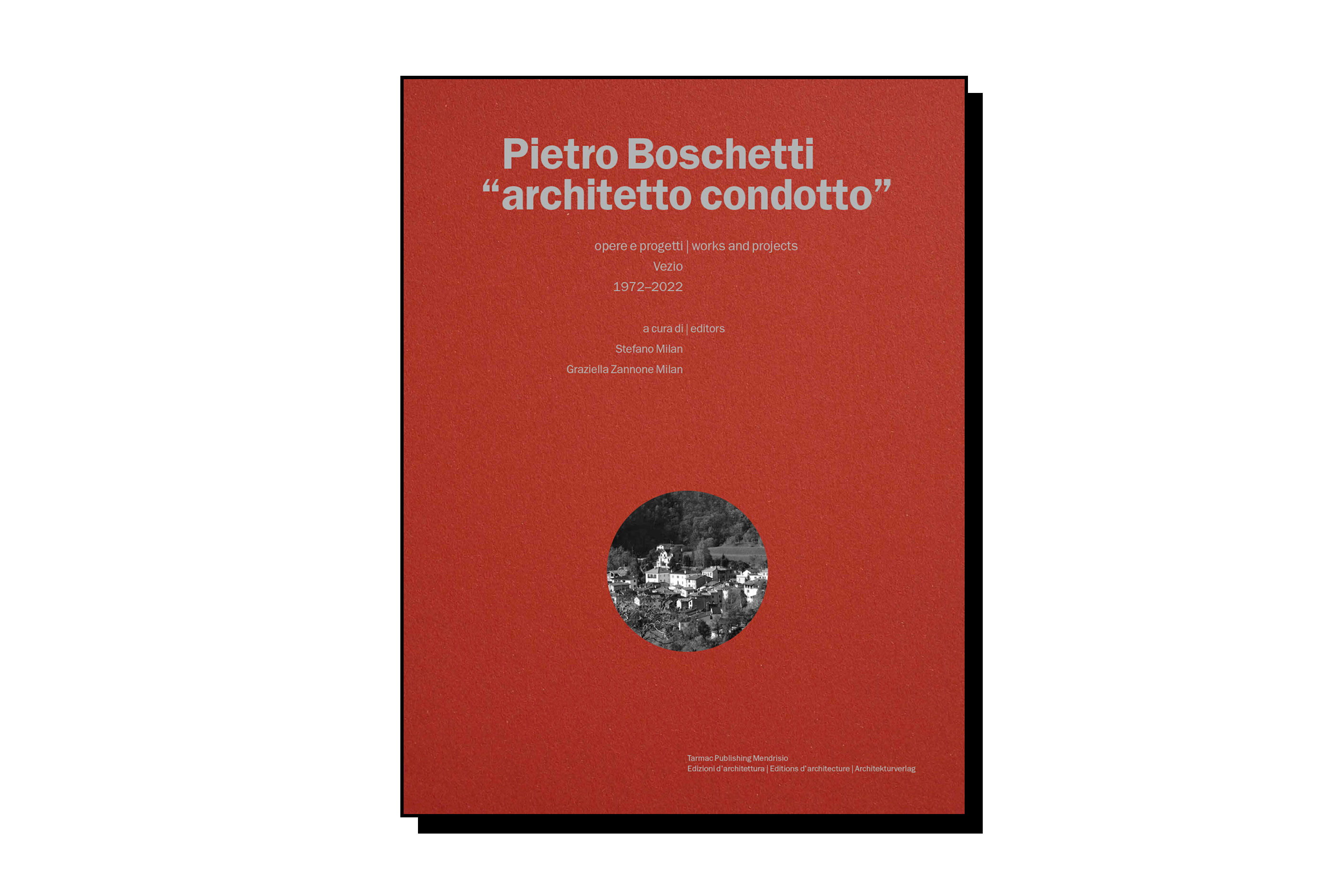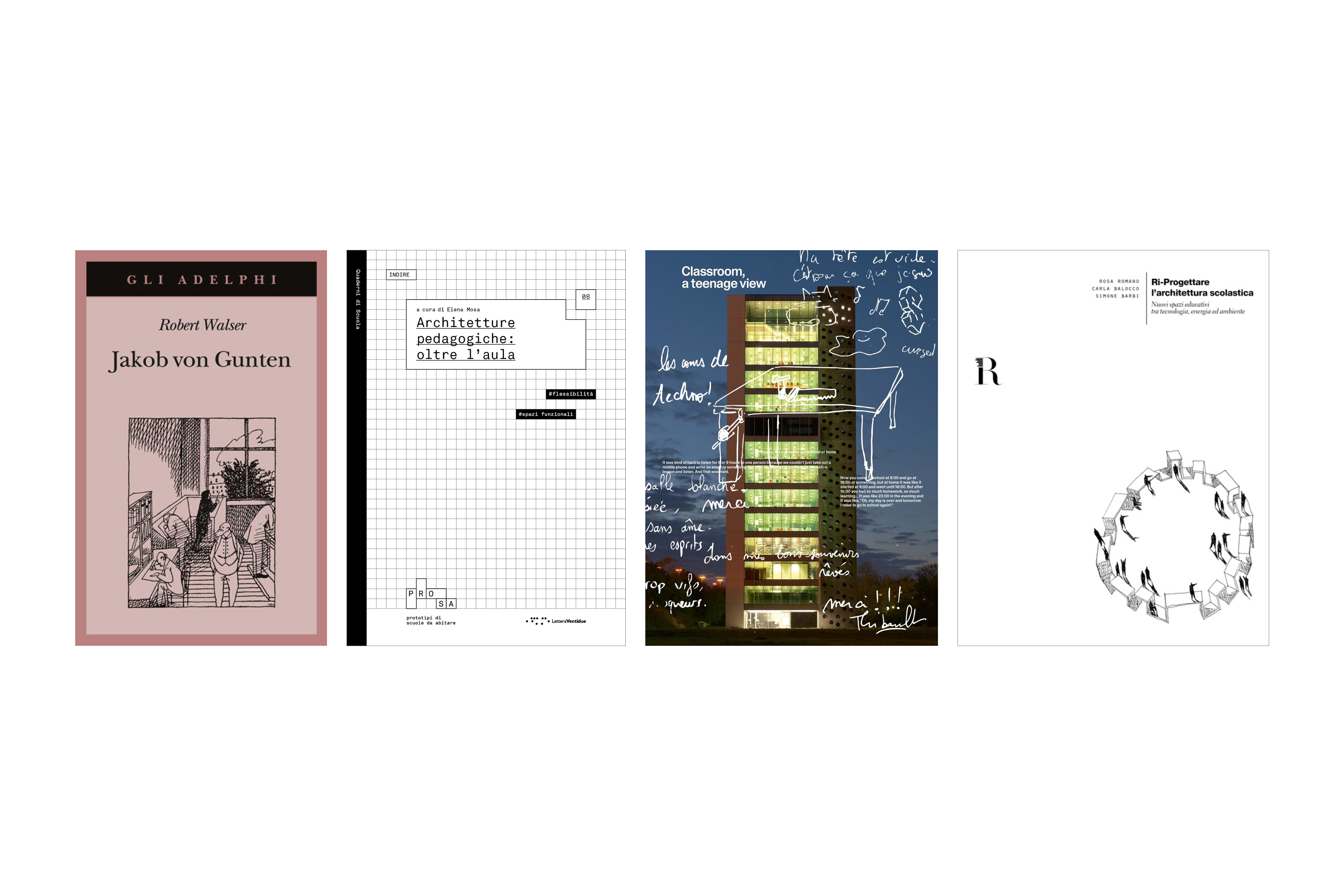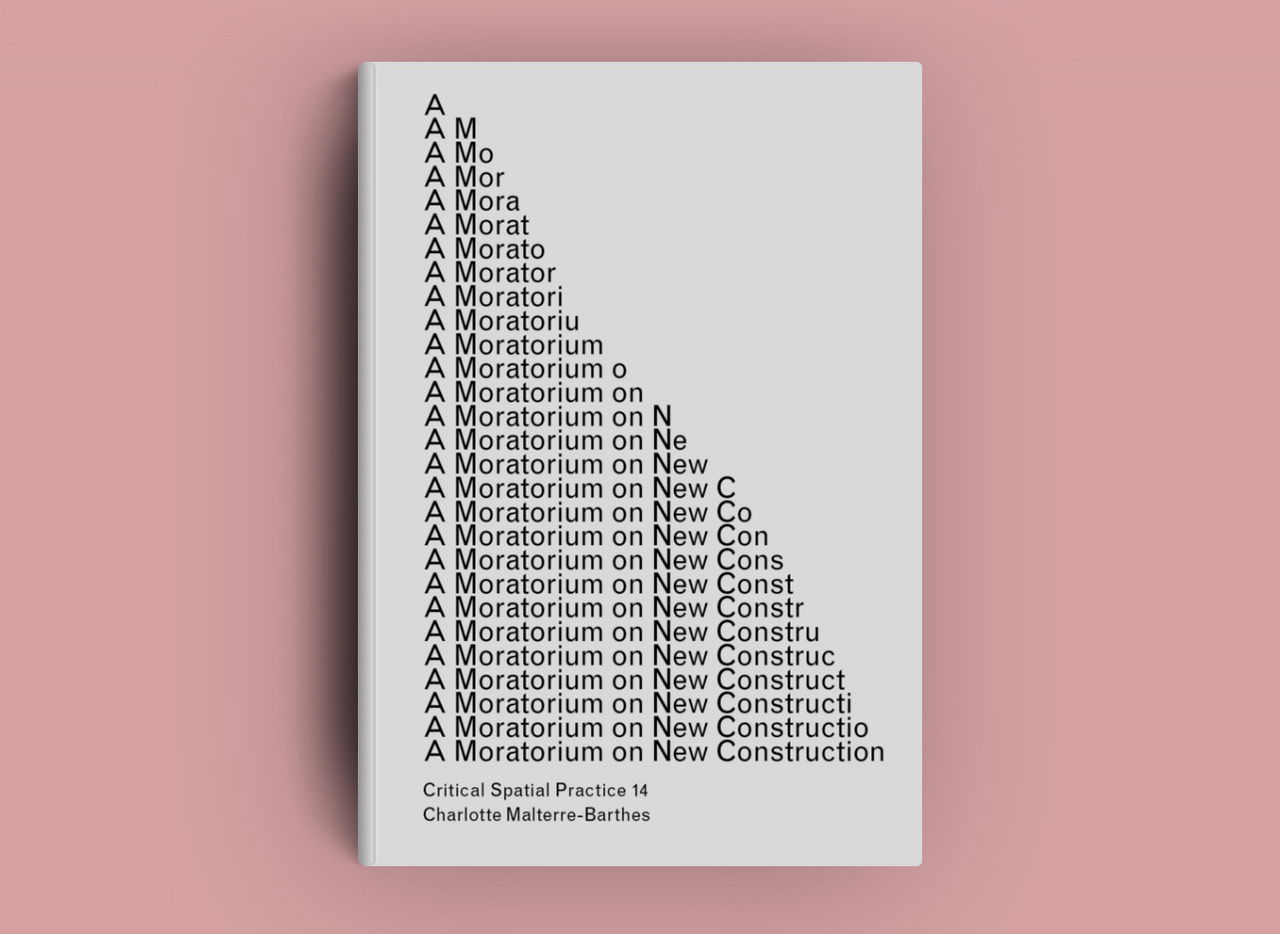Recensione del volume: Pietro Boschetti “architetto condotto”.
A cura di S. Milan G. Zannone Milan
Una recensione sentita del volume su Pietro Boschetti e le sue architetture per Vezio: un racconto limpido e partecipe di un modo di progettare radicato nei luoghi, attento alla storia e alle comunità, capace di rigenerare senza retorica un paesaggio vivo e condiviso.
C’è una traiettoria specifica del cinema italiano che annovera tra i capolavori “L’albero degli zoccoli” (1978) di Ermanno Olmi e arriva fino a “Vermiglio” di Maura Delpero (2024) che trae linfa vitale dall’osservazione e dalla trasposizione, apparentemente non mediata, di realtà marginali e inattuali raccontando piccoli mondi antichi dislocati in uno spazio e in un tempo solo apparentemente lontani.
Ecco, le architetture di Pietro Boschetti per Vezio sembrano parlarci delle stesse cose: di una relativa stabilità morfologica e figurale dei paesaggi esito di stratificazioni che Fernand Braudel direbbe di longue durée, di una ciclicità delle stagioni, di una sintonia con il luogo, di quel senso dell’abitare che Norberg-Schultz coglie perfettamente ancor prima di scrivere il suo libro più noto dedicato al genius loci. Di una naturalità del costruire, che poi è la maniera di stare al mondo dell’homo faber, che in primo luogo significa fare senza forzature. Ma c’è di più. Quello sguardo sagace e attento rivolto all’estensione temporale di un passato che arriva a noi rinnovandosi e arricchendosi ogni giorno, nel caso di specie è uno sguardo da architetto, colto oltreché operante, dunque capace di tessere relazioni fertili e generative con altri mondi, contigui e non, e con altri tempi, attraverso la frequentazione di un presente progressivo che si apre al futuro.
Nel suo pragmatismo operativo, che direi situazionale più che contestuale, come osserva Fulvio Irace, risuona l’eco delle parole di Bernard Rudofsky sull’architettura senza architetti e di Giuseppe Pagano sull’orgoglio della modestia.
Al cospetto dell’opera complessa e stratificata di ignoti costruttori, l’architetto non può che osservare – come accade in quel cinema sopra richiamato – tentare di comprendere le ragioni che sostanziano e informano le scelte compiute, rispondere a sua volta alle esigenze poste dalla contemporaneità, partecipando attivamente a un disegno già avviato da proseguire. Riscoprendo senza inventare, come egli stesso ci ricorda. Con umiltà ma con competenza, con la consapevolezza di colui che sa di intervenire sul corpo vivo di un tessuto fisico e sociale che dalla sua opera verrà, seppure minimamente, riorientato e condizionato.
Alberto Bologna, in questo senso, parla giustamente di co-autorialità, un concetto che esprime chiaramente questa relazione con coloro che sono intervenuti a conformare il contesto nel quale egli si trova a operare. E tuttavia possiamo parlare allo stesso tempo di coproduzione riferendoci alla comunità attuale committente essa stessa nel suo insieme, per mano di ciascuno dei privati che di volta in volta si rivolgono al progettista, che, obbligata in solido, si fa garante di ciascuno degli interventi.
L’architetto a sua volta parte di quella comunità dove tutti si conoscono, è forte di un mandato che va ben oltre la richiesta sporadica di un singolo, ma sa anche di assumersi una responsabilità della quale risponde quotidianamente, ogni qual volta incontra un proprio compaesano. È così che, come giustamente osserva Riccardo Bergossi, la parte viene di volta in volta concepita in funzione del tutto e il tutto rappresenta; che il rapporto tra privato e pubblico perde quella rigidezza propria dei confini; che le soglie si fanno oltre ogni retorica cara agli architetti, porose e abitabili; che “il progetto di riqualificazione della singola particella diventa, per forza, parte di un processo di rigenerazione urbana comunitario” (Bologna).
Nel suo ruolo, oltre a svolgere l’attività professionale, o meglio il mestiere, mette anche a disposizione le proprie competenze e il proprio amore per il territorio, prendendo parte alla vita attiva e facendosi promotore di una tutela prospetticamente intelligente – fondata sulla processualità coevolutiva che ciascun contesto contiene in sé e non su una sua istantanea ingiallita dal tempo – di un paesaggio di eccellenza. Proprio in questa modalità del prendersi cura di una salute pubblica che non è solo la sommatoria di quella dei singoli si completa quella figura di architetto condotto, già adombrata da Renzo Piano durante i laboratori sperimentali di Otranto nel 1979 e, a ragione, richiamata nel titolo di questo volume.
Questo libro nella sua lodevole e sintetica semplicità, restituisce tutto questo con eleganza e chiarezza, fugando tentazioni retoriche e celebrative, è perciò una testimonianza preziosa di una realtà che viene il desiderio di conoscere direttamente.
Pietro Boschetti “architetto condotto”
A cura di S. Milan G. Zannone Milan
Ed. Tarmac
Data di pubblicazione: agosto 2024