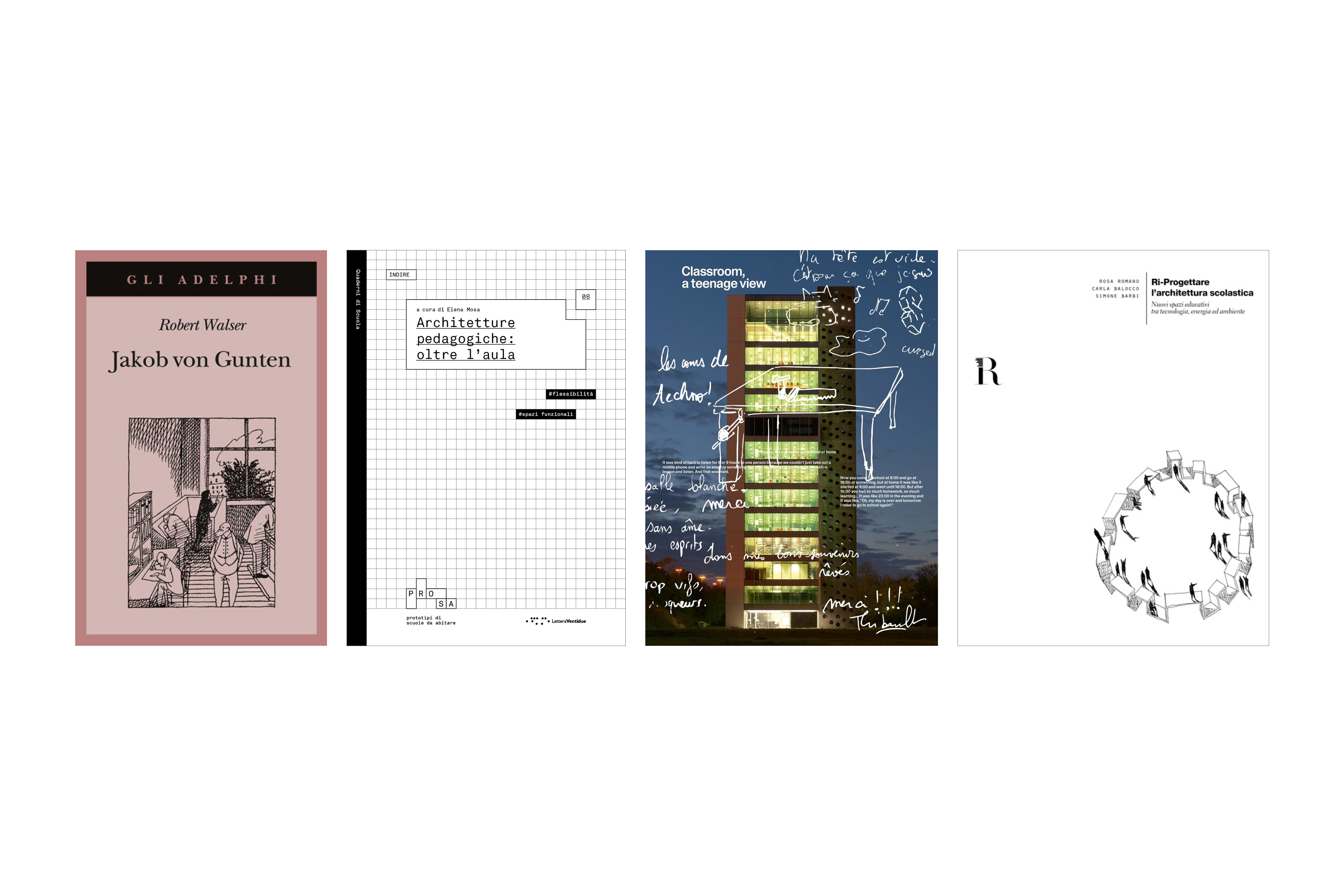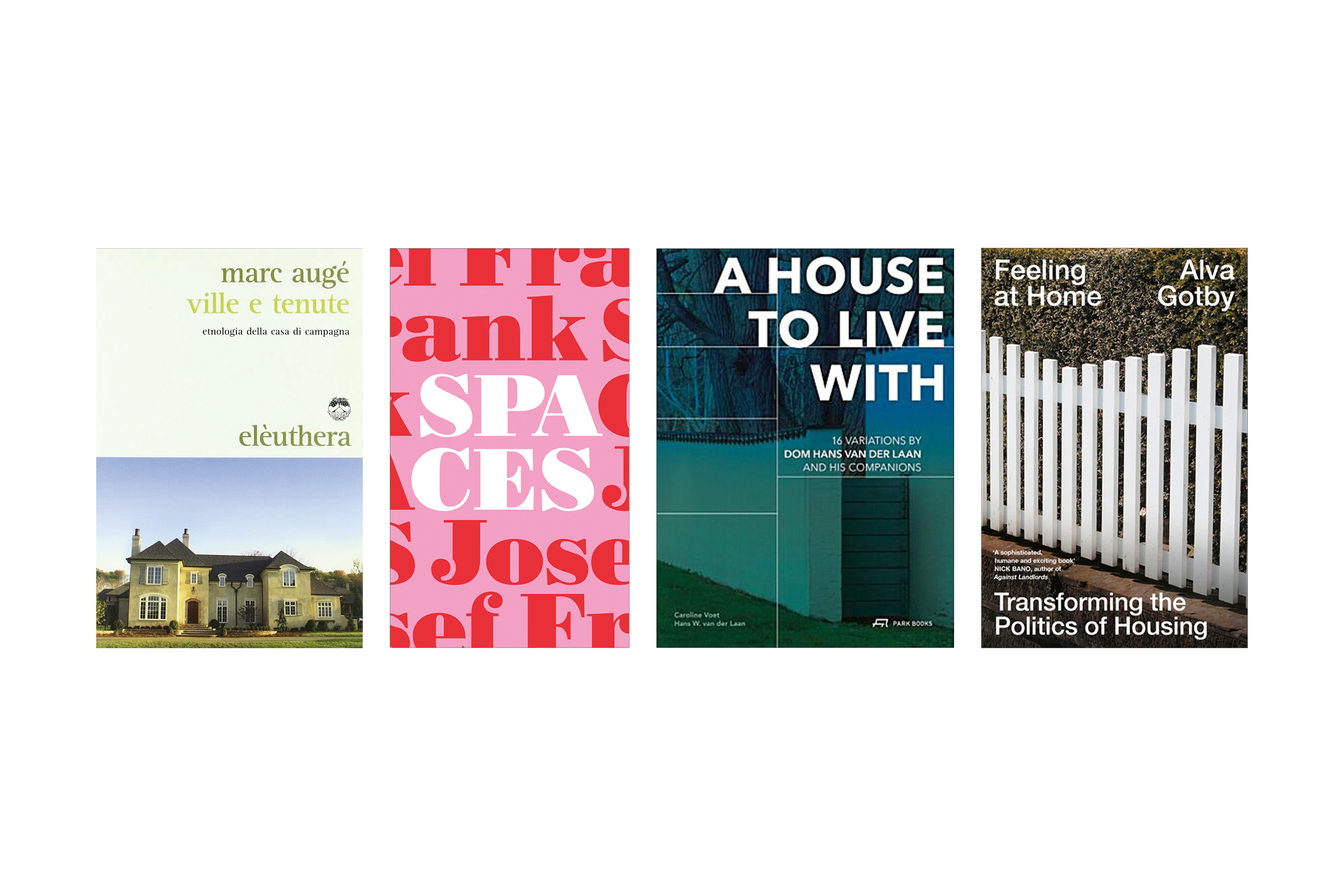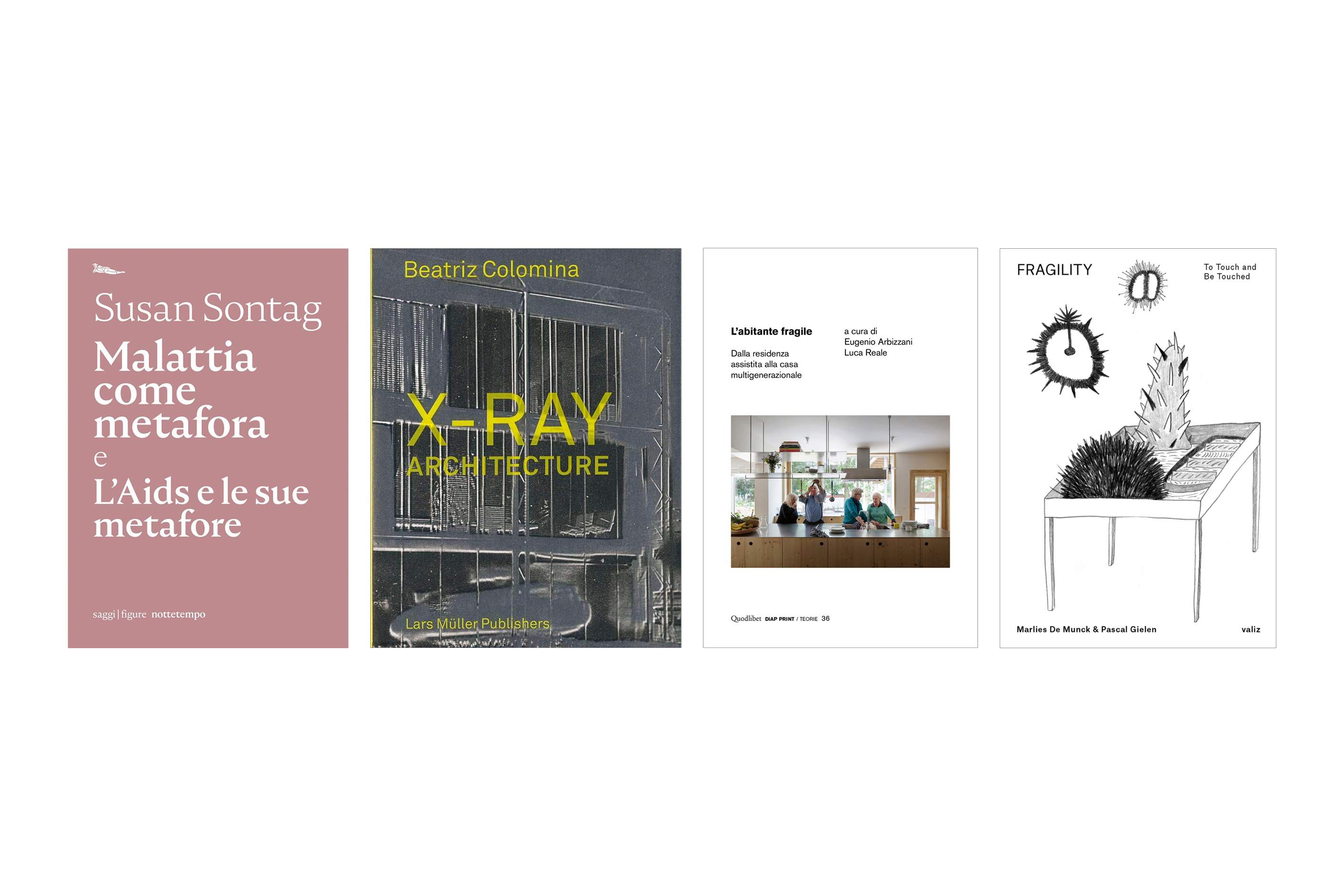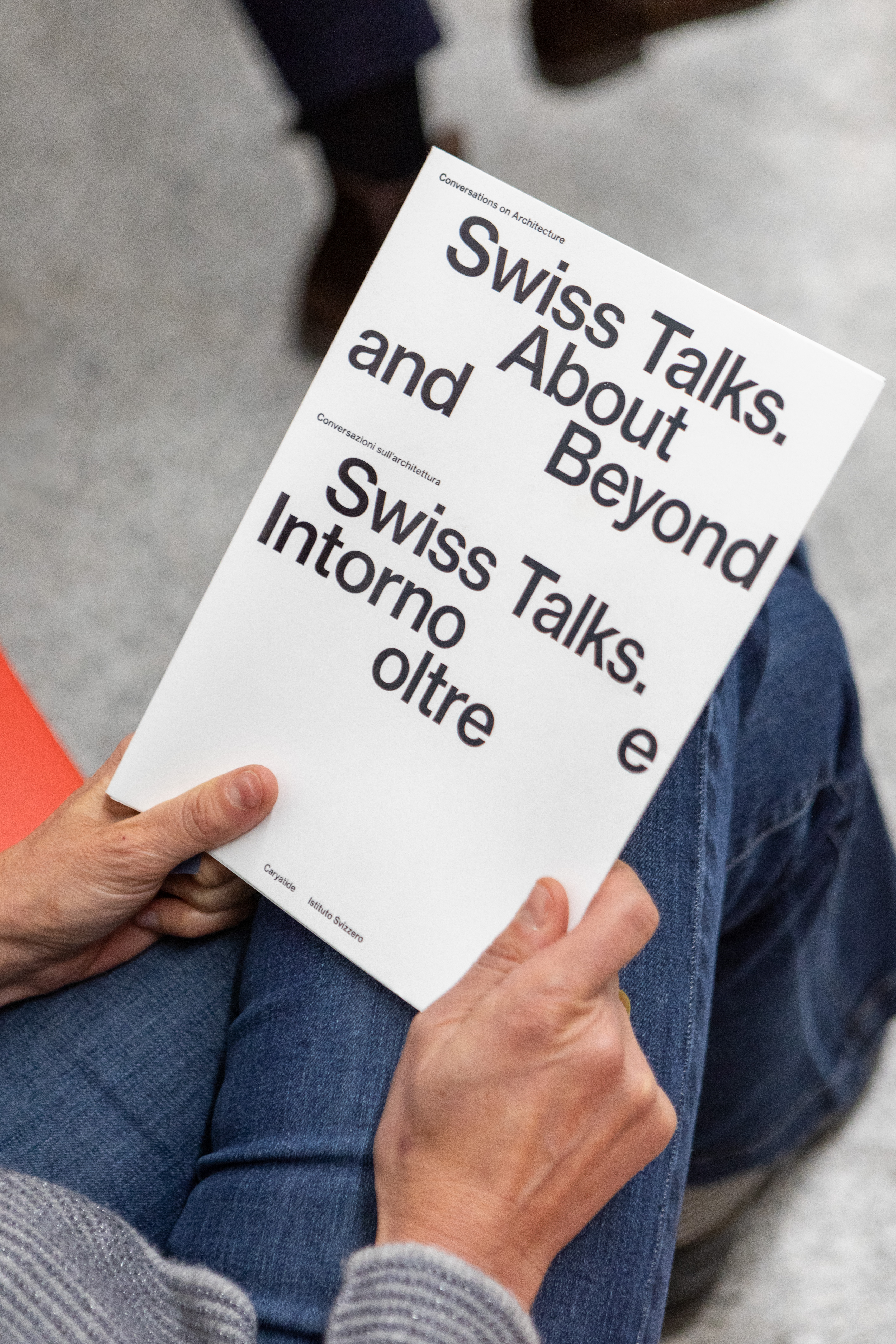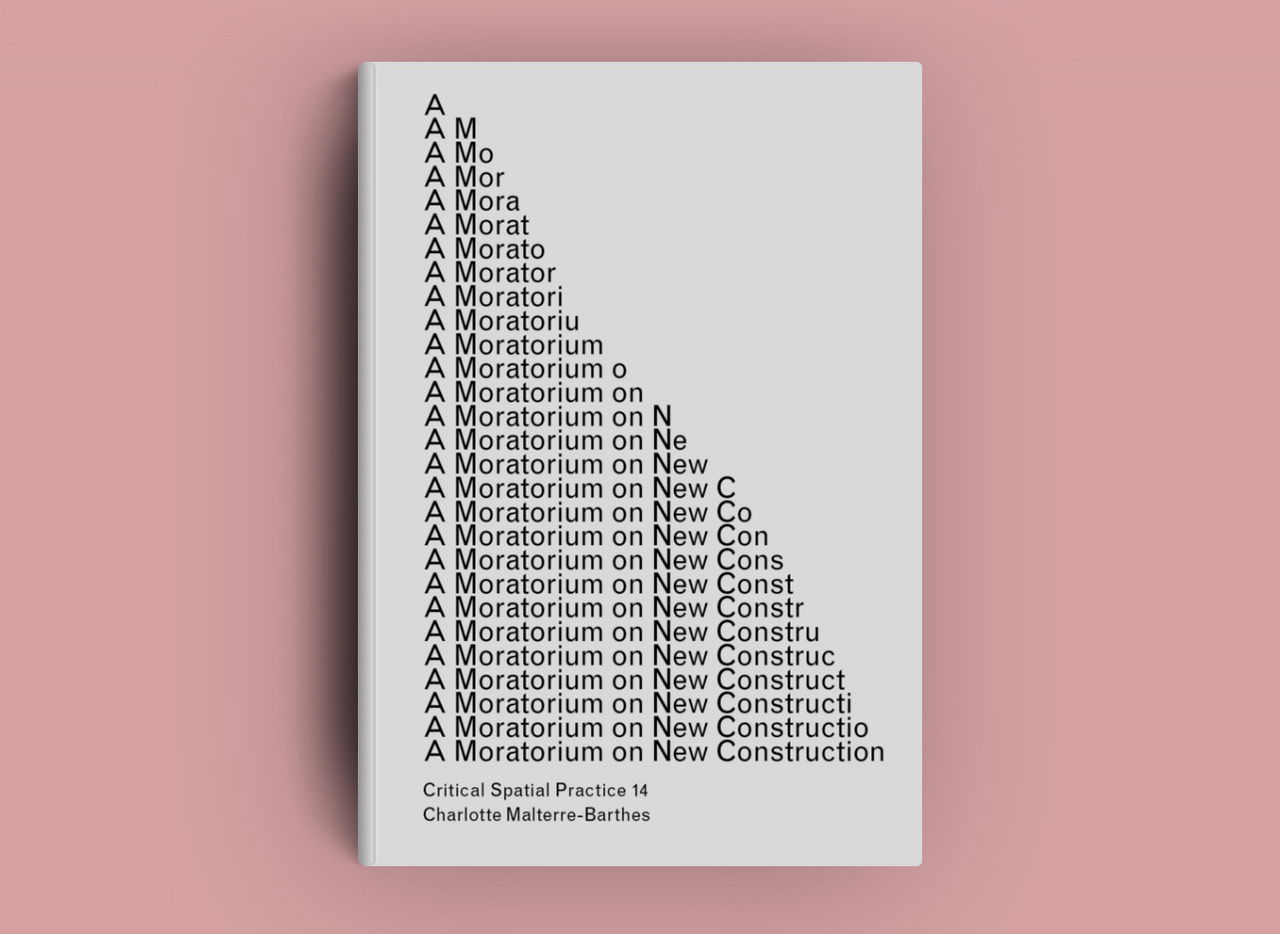Fili rossi
Nel secondo appuntamento della rubrica Libri di Archi, Fili Rossi, il tema della scuola si intreccia tra letteratura e progetto: dall’Istituto Benjamenta di Walser ai Quaderni di Scuola, fino alle ricerche sul riuso e sulla trasformazione degli spazi educativi nell’era post-Covid.
«Qui si impara poco, ma si apprende moltissimo» scrive sul suo diario Jakob von Gunten, il protagonista dell’omonimo romanzo-diario di Robert Walser, poco dopo il suo ingresso all’Istituto Benjamenta, il collegio che lo vedrà crescere e maturare, ma anche abbandonarsi alla malinconia e allo scorrere placido del tempo. In uno dei suoi romanzi minori, ma elogiato da autori del calibro di Walter Benjamin, Franz Kafka o Susan Sontag, Walser evidenzia la forte influenza che l’ambiente scolastico ha sulla vita di ognuno, in quanto luogo di confronto con l’altro e maturazione di una visione propria sul mondo, sebbene, nell’esperienza di von Gunten, l’ambiente scolastico pare impartirgli quella che è stata definita come «un’educazione a rovescio».
Ma quello di Jakob von Gunten non è certo l’unico diario di scuola: edita da LetteraVentidue, la serie Quaderni di Scuola condensa una ricerca articolata sull’architettura scolastica, declinata in una decina di uscite redatte da professionisti e accademici. Ogni numero esplora uno specifico tema – scuole e identità, scuole e pedagogia, scuole e modelli, scuole e riusi, scuole e città, scuole e paesaggi, scuole e interni – approfondito e analizzato attraverso saggi, progetti, indagini sul campo, testimonianze dirette, studi monografici su architetti e opere. Il quaderno si propone al lettore come uno strumento attivo, efficace nell’approccio alla progettazione, in un momento nel quale il ripensamento dell’ambiente scolastico torna, ancora una volta a rincorrere le trasformazioni del presente.
L’importanza di un luogo fisico capace di porsi allo studente come incubatore di idee e di crescita è risultata infatti ancora più rilevante all’indomani della crisi del COVID-19, una soglia storica dopo la quale la digitalizzazione dell’apprendimento ha costituito una nuova tappa evolutiva dell’ambiente scolastico. Questo passaggio epocale, e la sua influenza sulle generazioni che l’hanno vissuta durante l’adolescenza, è stata oggetto di studio di Classroom, a teenage view, il volume pubblicato nel 2024 da Puente Editores che ripercorre le tappe del progetto omonimo organizzato e promosso da arc en rêve centre d’architecture di Bordeaux, CCB/ Garagem Sul Architecture Center di Lisbona e Z33 House for Contemporary Art, Design & Architecture di Hasselt. Attraverso workshop, una mostra itinerante, un simposio e una piattaforma digitale, per culminare poi in questa approfondita pubblicazione, viene presentato un ritratto caleidoscopico di scuole, scandito da macrocategorie quali produzione, professione, espressione, ma anche trasgressione e assemblea.
Curato da Joaquim Moreno, il progetto Classroom a teenage view indaga il rapporto che intercorre tra l’adolescente e il suo spazio educativo, generando un ventaglio tipologico di spazi educativi disseminati su tutto il territorio europeo sviluppati dagli anni Cinquanta ad oggi, nel tentativo di rispondere alle domande: di quali tipi di ambienti di apprendimento abbiamo bisogno ora? Come possiamo adattare gli edifici scolastici esistenti per soddisfare queste nuove esigenze?
Il tema dell’adattamento dei complessi scolastici esistenti alle esigenze pedagogiche, tecnologiche ed ecologiche del presente costituisce il focus del volume Ri-Progettare l’architettura scolastica. Nuovi spazi tra tecnologia, energia ed ambiente: in un dialogo interdisciplinare Rosa Romano, Carla Balocco e Simone Barbi presentano appunti e riflessioni emerse dal lavoro progettuale svolto con gli studenti dell’Università di Firenze sul caso dell’istituto Don Milani di Firenze, al fine di andare a definire un approccio metodologico interdisciplinare e integrato al progetto di riuso. «Sottolineando l’importanza di ridiscutere sillogismi culturali relativi alla definizione stessa di “progetto”» il volume cerca di fornire strumenti utili ai giovani architetti per «raggiungere risultati funzionali che permettano di intraprendere percorsi di rigenerazione dell’ambiente costruito sostenibili dal punto di vista ecologico, energetico, sociale ed economico», scrive Barbi.
Dopo alcune considerazioni generali sui possibili approcci al progetto di matrice ecologica, il volume propone un ventaglio di esperienze scolastiche di interesse alla ricerca, per poi ripercorrere, nell’ultima parte, il lavoro svolto sul caso studio selezionato, e i risultati ottenuti in termini di riqualificazione urbana, architettonica ed energetica.
Sebbene Jakob von Gunten non si dilunghi, nelle sue pagine, in una descrizione meramente architettonica dell’istituto Benjamenta, possiamo immaginare che ciò fosse dovuto alla scarsa cura all’ambiente, che trasmetteva agli allievi un senso di scoramento e passività verso la vita. «Ma una cosa so di certo: nella mia vita futura sarò un magnifico zero, tondo come una palla» è una visione che si spera resti confinata nella letteratura e non diventi il destino degli alunni di oggi, progettisti di domani.