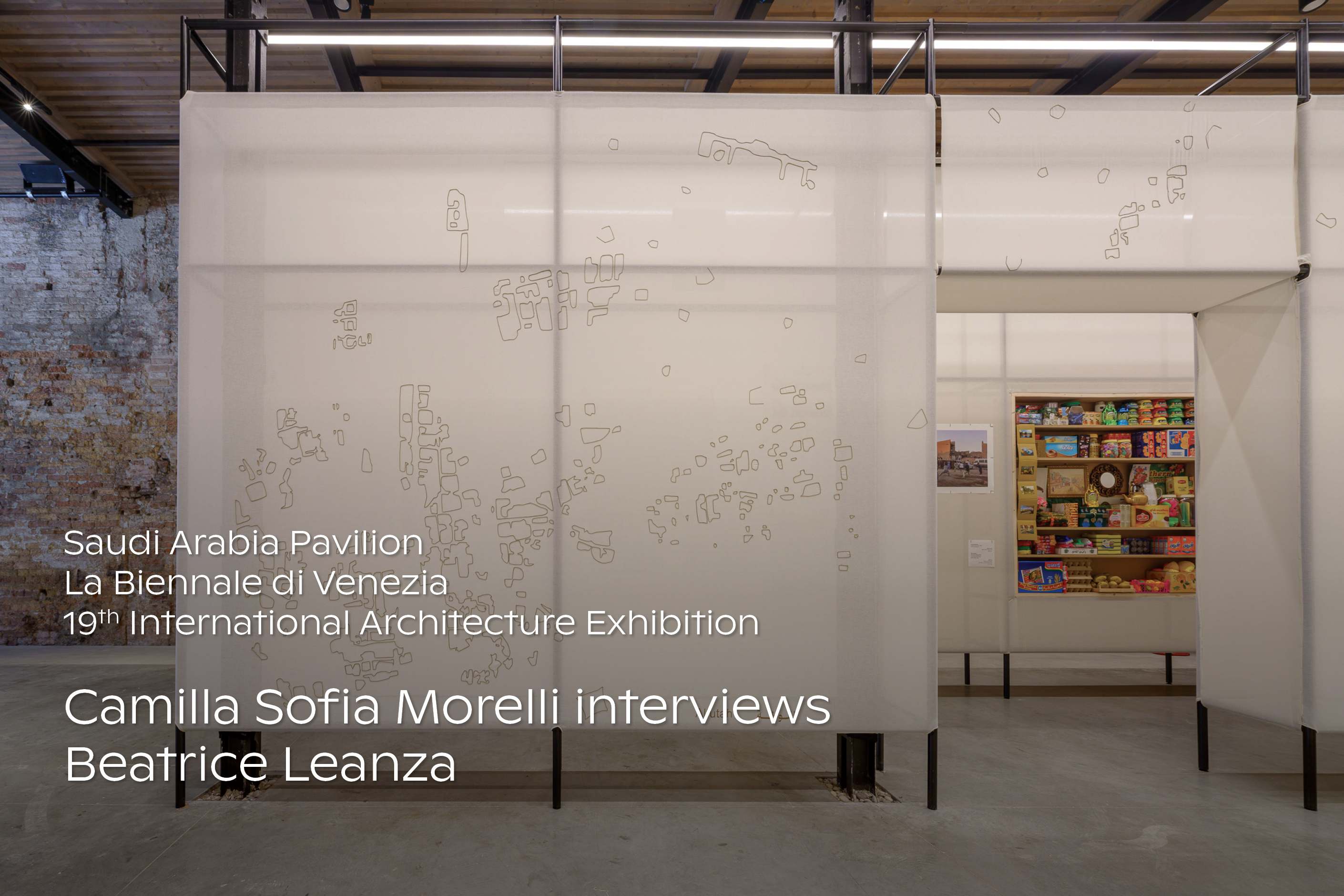Minority Report veneziano.
I temi della curatela e lo spazio della ricerca e del progetto alla Biennale Architettura 2025
Nel report dedicato alle Corderie della Biennale 2025, l’autrice analizza con sguardo critico punti di forza e fragilità della curatela di Carlo Ratti e delle numerose proposte in mostra, tra ambizioni tecnologiche e complessità espositive.
Ogni due anni, la kermesse lagunare propone un bilancio di salute delle discipline del progetto, stilato con un approccio il più possibile attuale e globale. La difficoltà risiede spesso, e lo abbiamo riscontrato anche nelle ultime edizioni, nella volontà di rendere mediatica, accattivante e “istagrammabile” una forma che, rimosso il make-up, si rivela spesso priva di sostanza.
Entrando alle Corderie dell’Arsenale si viene accolti da un breve testo del curatore Carlo Ratti che introduce le ragioni del titolo “Intelligens. Natural. Artificial. Collective”: la chiamata a indagare in tre sezioni le diverse forme di intelligenza naturale, artificiale e collettiva; segue una stanza surriscaldata dal flusso inverso dei condizionatori, che introduce il tema attraverso i sensi. La mostra vuole provocare, in sostanza, delle riflessioni originali sull’impiego dell’AI nel tentativo di costruire un nuovo metodo adattivo per far dialogare il mondo del progetto con i problemi concreti generati dal cambiamento climatico e dalle urgenze della “permacrisi”. Il problema è che, data l’originalità del tema se trattato in maniera non epidermica, molti dei lavori che se ne occupano veramente sono ancora allo stadio della ricerca e ad oggi non sono in grado di fornire un output, o di orientare un processo progettuale.
Oltre a questa difficoltà - che rappresenta al contempo una sfida e un pregio -, gli ostacoli che il visitatore riscontra sono numerosi: prima di tutto una curatela debole e farraginosa; poi un allestimento troppo denso, in cui si fatica a distinguere i progetti e a recuperare le informazioni; infine una grafica e un corredo testuale ridotti all’osso attraverso riassunti prodotti con AI, un dato riportato in tutti i cartellini della mostra, quando bastava esplicitarlo all’inizio e usare lo spazio per qualche preziosa informazione in più. Le attenuanti sono l’indisponibilità del padiglione centrale ai Giardini, chiuso per restauro, e di conseguenza la necessità di concentrare quasi tutta l’attività della curatela alle Corderie o disperderla in uno sprawl di interventi “fuori Biennale” nella città.
Eppure, data la volontà di impiegare nuove tecnologie, si poteva pensare ad un’espansione digitale dei sistemi informativi attraverso dei QR codes o altri meccanismi simili, in modo da non sacrificare la spiegazione dei progetti ed evitare che questa intelligenza artificiale degeneri in una balbuzie virtuale. Letture critiche severe sono rimbalzate sulle principali testate del settore nelle scorse settimane, portando a chiederci se c’è qualcosa da salvare e, nel caso, perché.
Il lungo cannocchiale visivo delle Corderie è ostruito dall’ installazione The Other Side of the Hill, curata dai teorici dell’architettura Beatriz Colomina e Mark Wigley insieme al fisico Geoffrey West e al biologo Roberto Kolter con la designer Patricia Urquiola. Una ripida parete rappresenta la crescita esponenziale che accompagna la società occidentale dalla rivoluzione industriale a oggi, punto di svolta in cui si assiste al collasso dei modelli finora sviluppati e ad un ripiegamento delle curve di crescita, che generano appunto l’altro lato della collina, ovvero il nostro futuro. Come modello alternativo alle città dell’era globale vengono proposte le forme aggregative sviluppate dalle colonie dei batteri, che si autoregolano bloccando la propria crescita quando rischia di superare un punto critico che porterebbe all’autodistruzione.
Segue lo scenografico allestimento del progetto Stonelife, che presenta le reazioni chimiche attivate dal microbiota naturale, potenziabile artificialmente, presente sulle superfici lapidee. Questo processo virtuoso permette di sottrarre carbonio all’aria sanificandola, ma viene minato dalla pulitura chimica delle facciate in pietra, che elimina la preziosa patina per restituirci le immagini da cartolina delle cattedrali bianche.
Numerose sono le riflessioni che mettono a confronto i meccanismi antropici con quelli naturali da un punto di vista strutturale e profondo, molto diverso da quello puramente epidermico, a tratti solo estetico, promosso dall’abusata bioarchitettura, che pure trova ampio spazio nell’esposizione veneziana.
Dopo le Biennali della spirulina, dei funghi e delle muffe, siamo ormai insensibili alle seduzioni del greenwashing, che occupa soprattutto la prima sezione dedicata all’intelligenza naturale, eppure nelle pieghe dei progetti “minori”, rappresentati sui pannelli laterali come nelle pagine di un fitto catalogo, si trovano diverse proposte interessanti, lontane quanto inattese, potenzialmente ricche. Il problema è, appunto, trovarle e prendersi il tempo di capirle. I progetti sono arrivati a Venezia grazie a un bando open call che per la prima volta ha permesso di superare i limiti dell’invito diretto e della conoscenza personale, ampliando enormemente gli orizzonti delle proposte. Purtroppo però, nella selva oscura dell’elencazione che cerca numeri da record (oltre 750 partecipanti!) ci si perde senza che la curatela appaia mai come un salvifico Virgilio. Verrebbe voglia di portarsi a casa il catalogo per poter approfondire, ma questo copioso materiale non vi trovava posto ed è finito negli omissis. Anche qui, date le premesse del tema, sarebbe stato utile e intelligente (qualunque forma di intelligenza vogliamo chiamare in causa) evitare che queste ricerche, per la prima volte radunate in un evento globale, non finissero nuovamente disperse, magari costruendo un sito internet con un catalogo virtuale, consultabile per temi e voci e ampliabile, uno strumento flessibile che rendesse la consultazione agevole nello spazio e nel tempo, in modo da accelerare un virtuoso processo di traduzione dall’esperimento al brevetto e infine al progetto. Perché questa è stata per secoli la storia dell’evoluzione tecnologica (e non solo) della nostra disciplina.
L’università tecnica di Monaco propone di integrare botanica e tettonica, facendo crescere ad esempio gli alberi sui giunti tecnici di una passerella pedonale: Baubotanik è una sorta di cyborg biologico, una nuova frontiera progettuale. Renzo Piano Building Workshop presenta il tetto verde della California Academy of Science di San Francisco, un progetto del 2008 di cui viene ribadito il successo, insieme alla tenuta nel tempo. I progetti realizzati in India da Anupama Kundoo integrano l’artigianato locale della terracotta opponendosi alla standardizzazione edilizia: in questo caso si parla di intelligenza collettiva e giustizia sociale, ma anche della riscoperta di pratiche vernacolari perfezionate nei secoli per ottimizzare la risposta a un dato clima, dunque ancora oggi auspicabili. Potremmo proseguire raccontando della più grande azienda agricola urbana dell’Asia, sui tetti del campus universitario di Bangkok, in grado di sfamare tutta la comunità accademica, ma lo spazio sarebbe sempre troppo poco per contenere un così vario caleidoscopio di proposte, che si auspica vengano sistematizzate in modo da formare una banca dati che potrebbe divenire un buon punto di partenza per poi tornare al progetto.
L’invito che ci sentiamo di rivolgere ai visitatori è a cercare bene lungo i margini, nell’attesa che qualcuno abbia finalmente il coraggio di proporre una Biennale dal titolo “Back to project”, in cui la disciplina possa ritornare al centro, con tutte le (pacifiche) armi che possiede e che ci rifiutiamo di considerare spuntate.