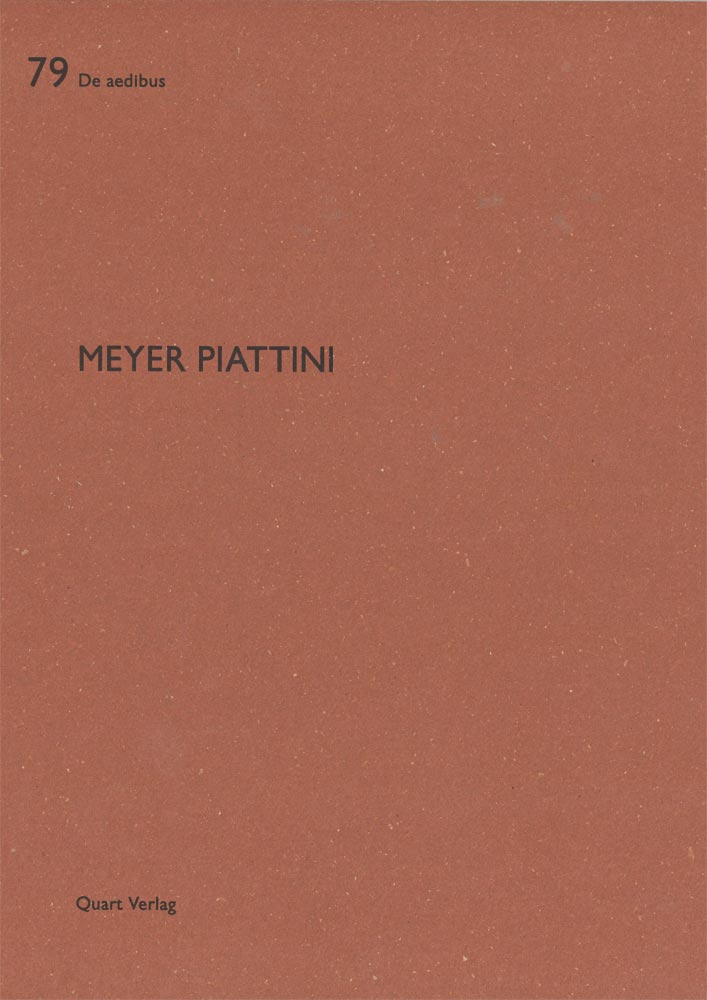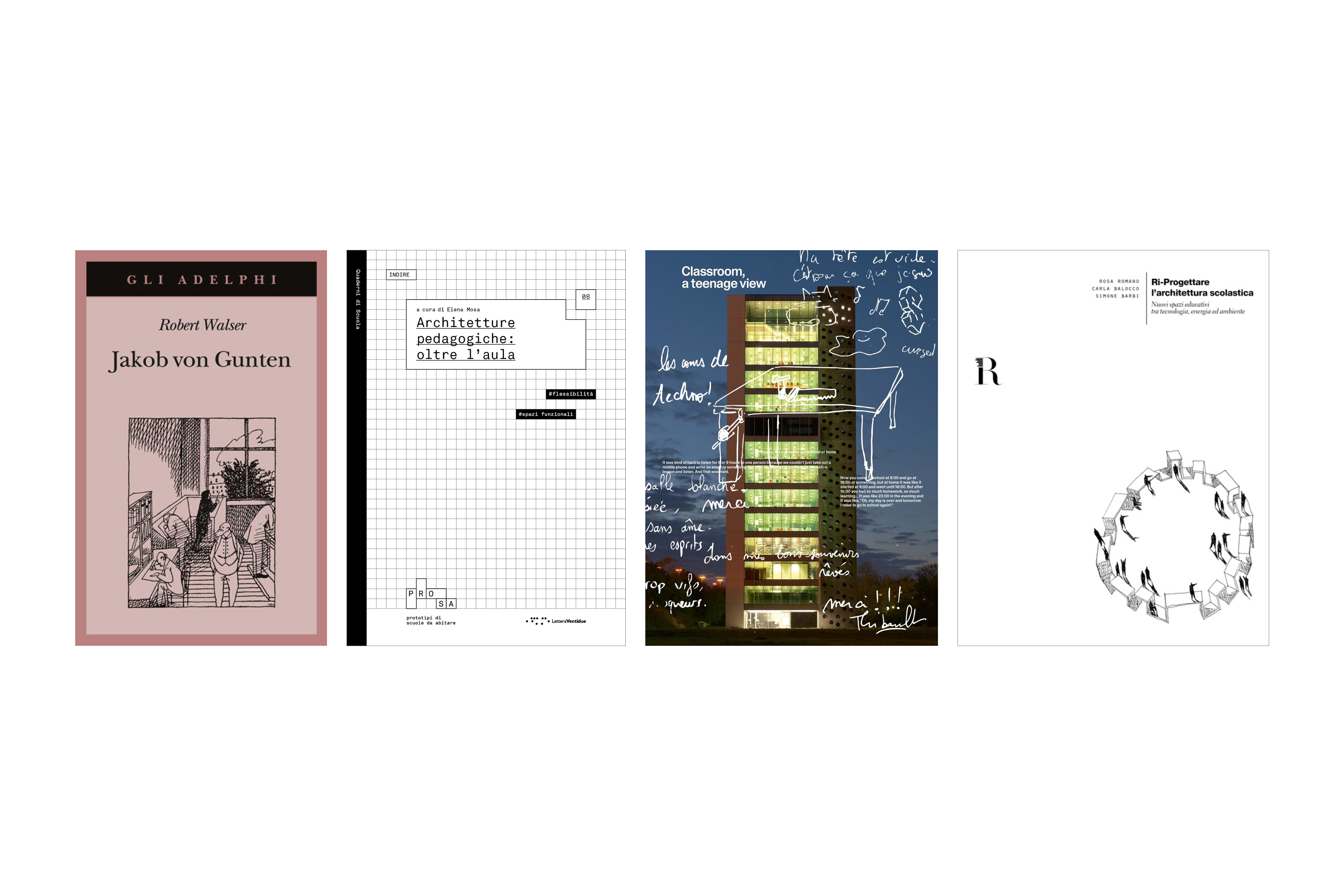20 anni di libri Quart
Per l'occasione, un estratto dal volume sullo studio Meyer Piattini
Con le ruvide copertine garbatamente marmorizzate della serie De aedibus ha creato un atlante aperto dell'architettura contemporanea in Svizzera; con serie e monografie successive ha perseguito una linea dove la qualità grafica e tipografica risponde all'attenzione per i progetti in esame. Da vent'anni Quart Verlag, casa editrice specializzata in architettura con sede a Lucerna, lavora alla costituzione di «una forma di memoria architettonica», come scrive il co-fondatore Heinz Wirz nel nuovo editoriale di De aedibus. Per festeggiare questo anniversario proponiamo un saggio dello scrittore Oliver Scharpf da uno dei volumi più recenti di Quart: quello dedicato ai lavori dello studio Meyer Piattini di Lamone.
Stopacüü, Johanniter, e finestre filomuro
Dalle finestre dello studio meyer e piattini, alle spalle della fermata ferroviaria di Lamone, al mattino presto a fine novembre, quando i boschi sono già abbastanza spogli, si vede là in alto una luminescenza intermittente. Sono i fari delle macchine che vengono giù dalle tortuose curve della Penüdria, leggendaria strada ripida nel bosco che collega il Malcantone con la piana del Vedeggio. Un caffè al volo e al lavoro anche noi. In macchina e via, verso la casa colonica di Ira Piattini. Lukas Meyer al volante mi fa notare, subito dopo la rotonda, uno dei loro lavori più recenti. La nuova sede del Credit Suisse che vedo di sfuggita. Con la coda dell’occhio agguanto la regolarità delle grandi finestre illuminate che rendono monolitico l’edificio in cemento faccia a vista. Sull’autostrada, dopo i centri commerciali di Grancia, lassù a Barbengo si acciuffano con lo sguardo le case unifamiliari disegnate tra il duemilasette e il duemilaotto: la terza tappa prevista della nostra passeggiata architetturale.
Per la prima, a Maroggia, prendiamo la strada che sale su verso Arogno. A una curva, in frazione Piazzo, svoltiamo a destra in una stradina sterrata. Già il cancello, la cui ramina ricamata in modo graziosamente bucolico-contemporaneo dice molto sull’attenzione naturale ai dettagli. Un gatto nero sfreccia via tagliandoci la strada, ma da gattomane lo ritengo un buon segno.
Siamo in una piega dolce della Val Mara dove una vecchia casa rurale in mezzo a un vigneto è stata ristrutturata con cura da Ira Piattini e il suo compagno Paolo Merzaghi, ai quali stringo ora la mano. Sul camino, un pastello nero carbone del millenovecentoventidue firmato con le iniziali WR racconta bene tutto questo angolo di mondo. «Della bellezza del vigneto si parla anche in un articolo del millenovecentoundici sulla "Gazzetta ticinese"» mi dice fiero Paolo Merzaghi.
In giro, lampade come la Toio di Achille e Pier Giacomo Castiglioni o l’alogena di Joe Colombo e xilografie di Teresa Leiser Giupponi denotano un certo stile. Ma la vera eleganza spontanea va scoperta nel parquet proveniente dal Mulino di Maroggia e nelle finestre fatte con il legno di un noce che stava in via al Chioso a Lugano, dove andremo dopo, a vedere un palazzo. Lo studio era il fienile. Nell’orto colgo due foglioline di timo e lo stropiccio con i polpastrelli per sprigionarne l’odore. «Da buoni neorurali» mi dice divertita Ira, «avevamo spostato l’orto là, ma non c’era sole, la posizione originaria era quella giusta».
La casa risale al Settecento. La facciata, non stravolta da interventi invasivi, la si può gustare a fondo, ripercorrendo le varie epoche attraverso la magnifica eterogeneità dei mattoni. «Stopacüü» dice Lukas a proposito della rosa canina che cresce contro le mura. Imparo così una nuova parola in dialetto, precisissima e divertente. L’agave all’entrata e gli ulivi spaesano un po’, spostando l’immaginario, per cinque secondi circa, in una tenuta in Toscana. Dal finestrino si capisce che ora passiamo nel punto esatto in cui William Ritter (1867-1955) – pittore marginale giramondo e critico musicale esperto di Mahler nato a Neuchâtel e morto a Melide – ha cristallizzato il paesaggio a colpi di pastello. I pendii avvolti dalla bruma novembrina mi danno sempre una calma estrema. «Johanniter»: vitigno nato nel sessantotto, risalta, tra gli altri più conosciuti elencati da Ira a proposito del vigneto di casa. Da ritenere, al pari della rosa canina in dialetto, come parola-mantra del giorno. Sul versante opposto, ai piedi del Monte Generoso, un po’ prima di arrivare ad Arogno, avvistiamo la nostra prossima meta. Dopo l’ex fabbrica di orologi in stallo da decenni, a sorpresa, appare una coltivazione potenziale di alberi di Natale. Ma il nostro viaggetto architettonico è da un vigneto all’altro.
Innestata nel terreno terrazzato senza nessun fronzolo, la cantina Bianchi potrebbe sembrare a prima vista molto brusca. Benché sia la prima rapida impressione, la ritengo comunque una qualità. Di certo è diretta, dura, cruda, chiara, essenziale, zero bla bla bla. Sulla facciata ci sono le delicate tracce dei casseri che ricordano il beton gettato in opera della Congiunta di Giornico. Tra l’altro, anche lì, accanto a quell’anomalo museo a metà strada tra lo stato brado e il self-service nato nel millenovecentonovantatré per mano di Peter Märkli, ci sono dei vigneti; gli ultimi del Ticino. Il beton, avendo osservato quello a Giornico, si vede che è stato concepito per abbellire con il passare del tempo e il succedersi delle intemperie. Dentro, aprendo una botola, Ira mi mostra il principio con il quale è stata concepita la cantina: la gravità. Il mosto cade con naturalezza nei tini attraverso questa botola. Niente stress. E le facce gioviali dei due giovani fratelli Bianchi – Martino e Gabriele – all’opera, la dicono lunga riguardo gli effetti benefici di questo faticoso mestiere sullo spirito. Oltre al beton, le parti in metallo di questa cantina gravitazionale sono verde salvia. Scendiamo nel tepore della barricaia dalle luci soffuse dove si potrebbe stare ore in meditazione. Sulla strada, all’altezza delle scuole elementari di Arogno, tiriamo sotto un pallone. Torniamo indietro a redimerci, consolando come possiamo il bambino incupito con in mano il suo pallone annientato. La maestra apprezza il nostro passo indietro invece di fregarcene e tirare dritto.
Una vigna anche qui a Barbengo, giallo oro che vira al marroncino chiaro accordandosi alla perfezione con gli atipici rolladen in legno. In ogni giardino delle cinque case unifamiliari, i due architetti, sette anni fa, hanno disposto che venissero piantati dei brevi filari di vite. Per ricostruire la vocazione perduta di questo terreno terrazzato, un tempo coltivato appunto a vigna. E al contempo per dare unità alle cinque case grandi uguali ma tutte leggermente diverse e costruite ad altezze diverse, seguendo la morfologia altalenante del luogo. L’unità tra le case con il profilo del tetto a zig zag è data anche soprattutto dalle mura continue che uniscono. Come le case in un vecchio nucleo con una piazza, qui c’è uno spiazzo comune. Colpisce subito l’irregolarità garbata della facciata. «L’obiettivo era farla vibrare» rivela Ira. Due di queste facciate tremule per ogni casa sono verniciate in bianco: il movimento vibrato ne risulta così accentuato.
Via al Chioso è una via perpendicolare al corso cittadino del Cassarate che scorre a pochi passi da qui. Dove, si sa, segna l’inizio del quartiere di Viganello. Il nome della via e i numeri civici giganti, otto e dieci, sono ribaditi sulla facciata su idea del grafico Alberto Bianda. Per questo stabile amministrativo, attaccato alla Fidinam del Botta, «l’ispirazione sono stati i palazzi milanesi del duo Asnago e Vender» mi svela Lukas. Le grandi «finestre filomuro», come qui, sono una delle loro caratteristiche. Al contempo però la parvenza di fabbrica spinge la memoria, per un paio di secondi, quasi più a nord. L’aria nordica è rafforzata dalle felci selvagge ben strutturate in aiuole zincate pensate dalla paesaggista Sophie Ambroise: l’artefice della rinascita della foce del Cassarate. In direzione del Monte Bré, su una facciata campeggiano, maiuscoli ed enormi, sette versi di Davide Monopoli, poeta luganese partito, pare, per la Provenza: Qual / cosa / fora / e – anche / senza / parole / parla. All’angolo inizia via agli Orti, dove nei primi anni Novanta ricordo vernissage vari, concerti jazz, e soprattutto un’epica serata con un inarrivabile one man show di Cito Steiger, l’indimenticabile Gigi Piantoni televisivo. Lukas si ricorda benissimo del posto perché ci lavorava, condividiamo così uno sprazzo di sana nostalgia felice.
Ripartiamo per percorrere tre isolati e svoltare in via Vicari, appena dopo il famigerato bar Carosello e un po’ prima del campetto sportivo. Qui, all’angolo con via Maggio, dal duemilaquindici sorge una casa d’appartamenti che si potrebbe sintetizzare come «un Chiattone rivisitato». Una donna con un trench caffèlatte e zeppe entra dal cancello turchese scuro. Il trench è quasi in tinta con il palazzo beige-rosa i cui balconi iperarrotondati per certi versi richiamano anche un edificio degli anni Trenta di Orfeo Amadò affacciato su piazza Pelli. Le nove finestre filomuro a forma di goccia sfuggono a ogni associazione mentale o classificazione emotiva, benché la direzione sia quella navale degli oblò. Qualcosa, in fondo, chissàperché, mi richiama Miami. La Miami di Miami Vice, va da sé, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo.
Il testo di Oliver Scharpf è tratto dal volume Meyer Piattini (Quart Verlag, collana De aedibus 79, ottobre 2019).