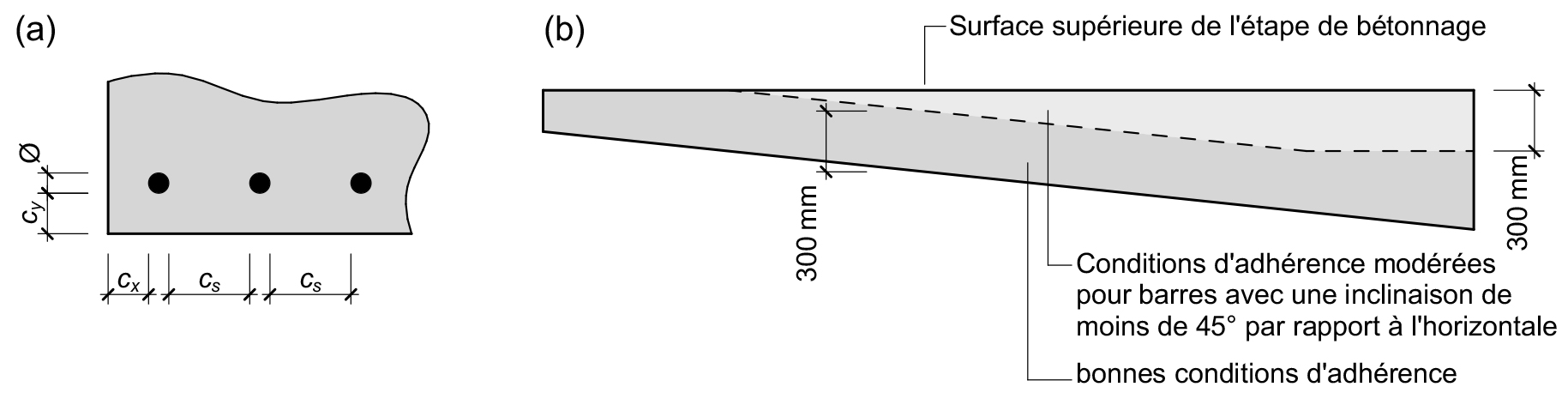Il cemento degli artisti
Intervista ad Anna Rosellini
Cemento: non solo materiale costruttivo per l'edilizia, ma anche materia su cui l'arte ha basato opere, indagini, esperienze capaci, da lì, di tornare a ispirare architettura ed ingegneria. Gabriele Neri ne ha parlato con un'esperta.
Ingegneri e architetti, non siate gelosi né presuntuosi: il cemento non è solo affare vostro. Ne conoscete molti aspetti ma mica tutti: la storia dell’arte del Novecento ci svela innumerevoli esperienze in cui questo materiale – nelle sue variabili composizioni – è stato condotto ben oltre i confini del cantiere edilizio, arricchendosi di significati. Chi li conosce bene è Anna Rosellini, che da ormai molti anni (a cominciare dall’attività presso l’EPFL all’interno del progetto di ricerca guidato da Roberto Gargiani) studia il cemento nelle sue varie forme. Prima quelle degli architetti (Le Corbusier e Kahn), ma poi anche le riflessioni degli artisti, scoprendo influenze e debiti tra i due mondi confluiti in due libri: Valori primordiali e ideologici della materia, da Uncini a LeWitt. Sculture in calcestruzzo dal Novecento ad oggi (Aracne editrice, Roma 2018), scritto insieme a Roberto Gargiani, e Calchi di spazio, mnemosine e rovine. Sculture in calcestruzzo dal Novecento ad oggi (Aracne Editrice, Roma 2019). L’abbiamo intervistata.
Gabriele Neri – Hai scritto molti libri sul calcestruzzo. Com’è avvenuto il passaggio dallo studio del cantiere edilizio alla dimensione artistica?
Anna Rosellini – Approdare all’arte è stato abbastanza semplice, perché l’inizio del mio confronto con il cemento è stato Le Corbusier. Fu lui uno dei primi a porsi fino in fondo la questione della dimensione artistica dell’architettura e dei materiali, trovando nel calcestruzzo delle componenti importanti, non solo legate al «disegno» della sua superficie con le casseforme, ma anche operando alcuni paragoni fondamentali. Quando parla di béton brut, Le Corbusier lo paragona al bronzo, riportando la tecnica del getto del conglomerato a quella scultorea della fusione. E lo fa anche in seguito a un contatto diretto con Picasso che lavorerà con il calcestruzzo dopo aver visitato il cantiere dell’Unité d’Habitation di Marsiglia. Procedendo con le mie ricerche mi sono così accorta come anche gli artisti abbiano interrogato la natura di questo materiale da costruzione, ponendosi quesiti che sono simili a quelli degli architetti.
Uno dei temi di comune riflessione è di certo quello del processo: il materiale che deve essere selezionato, miscelato e messo in opera per raggiungere una forma prima inesistente. Come si è sviluppato questo discorso nell’arte del secondo dopoguerra?
Già alla fine degli anni Cinquanta un artista come Giuseppe Uncini ha guardato la costruzione nei cantieri per riformulare i criteri tecnici e figurativi della propria disciplina. Quando scopre il cemento, lo elegge a materiale privilegiato. Comincia la sua ricerca a Roma, interessandosi alle strutture in ferrocemento di Pier Luigi Nervi: visita i suoi cantieri per i Giochi Olimpici del 1960, inizia una serie di opere intitolate Cementarmati e propone una sua versione del ferrocemento. Uncini porta il cemento armato nella sua dimensione disciplinare, usa quel materiale e il suo processo di messa in opera per ridefinire la natura stessa del quadro che diventa simile a un pannello edile, fatto di fili di ferro e cemento. Non a caso Uncini definisce le proprie opere «non-quadri».
Siamo in un momento storico in cui il cemento fa parte dell’immaginario collettivo.
Negli anni della ricostruzione, dopo la seconda guerra mondiale, gli artisti vedono le ossature in calcestruzzo armato dei cantieri e rimangono affascinati anche dalla possibilità di sviluppo sociale che esse rappresentano. Certo gli artisti avevano già utilizzato il cemento, ma in maniera più funzionale: per la copia di sculture, o per opere da realizzare all’aperto… però una modifica radicale del loro modo di manipolare il cemento avviene e si generalizza soltanto nel dopoguerra, quando gli artisti iniziano a considerare la natura della materia e il suo processo di messa in opera.
Legate all’atmosfera economica e sociale degli anni Sessanta sono anche le esperienze dell’Arte povera, che infatti si confrontarono con questo materiale.
Alighiero Boetti o Gilberto Zorio, ad esempio, erano interessati non solo al cantiere ma anche ai depositi edili, alla produzione industriale dei derivati del cemento, come l’eternit, un materiale che iniziò ad avere un ruolo nella società e nella produzione dell’epoca. Oltretutto, il padre di Zorio era un imprenditore edile. L’eternit diventò fondante per la realizzazione di opere che non sono nient’altro che accumulazioni di prodotti industriali da cantiere, come la Catasta di Boetti del 1966. Quel modo singolare di considerare i prodotti edili e il loro stoccaggio quali nuove forme artistiche ha poi avuto conseguenze in architettura. Si pensi a Jacques Herzog che nel 1986 fece una scultura che richiamava l’opera di Boetti, oppure a opere di Herzog & de Meuron come il deposito della Ricola ideato quale altra «catasta».
In quegli anni le riflessioni della cultura architettonica si intersecano frequentemente con quelle dell’arte: penso al periodo radicale.
Simili legami sono molto evidenti nel campo della Land Art. Penso a Walter De Maria: la prima versione della celebre opera One Mile Long Drawing (1968) fu pensata come 2 muri in calcestruzzo bianco, alti e distanti 12 piedi, e lunghi 1 miglio. Non riuscì a realizzare questa versione e ripiegò sul solo tracciamento al suolo di due linee in gesso, come accade nei cantieri per indicare il perimetro degli edifici prima dello scavo delle fondazioni. Quell’immagine, com’è noto, diverrà parte della storia del Monumento Continuo di Superstudio.
Queste intersezioni che ragionamenti stimolano?
Molte volte, quando si studia l’arte ci si dimentica di quanto anche gli artisti siano legati agli aspetti materiali. Ad esempio, le considerazioni di Robert Smithson sui cantieri restano ancora oggi fondamentali per sviluppare una visione dell’architettura. È lui ad aver proposto uno straordinario ragionamento sul concetto di rovina processuale, dipendente dalle fasi costruttive che accadono in cantiere. Quel cantiere diventa sinonimo di Ruin in reverse, ovvero uno stato in cui l’opera non ha ancora assunto una funzione, e perciò può diventare un’opera d’arte astratta nel paesaggio (oppure, se rimaniamo nell’ambito del progetto, un’architettura altra). Un simile punto di vista mette in discussione il concetto di tempo necessario per creare la rovina romantica. Qui è il contrario: il tempo è un istante. Il concetto di Ruin in reverse diverrà il presupposto di un atto creativo che Smithson sperimenterà e che prenderà la definizione di de-architectured project.
Un ribaltamento prospettico. Non è l’unico: penso al punto di vista di Pierre Huyghe che citi nei tuoi studi.
Nel 1993 Pierre Huyghe, insieme a un fotografo, compie un viaggio in Italia per realizzare un libro a partire dal film Uccellacci e uccellini di Pasolini. Voleva fotografare gli stessi luoghi che avevano fatto da sfondo al film e vedere come si erano sviluppati. Quindi ritrae le ossature in calcestruzzo armato, incomplete, di quei paesaggi. È affascinato da quelle carcasse che possono essere progressivamente completate, e nelle quali intravede la possibilità di attivare un processo di vita sociale che non necessariamente deve avere una conclusione. Il suo modo di guardare quelle ossature incomplete recupera le potenzialità tecniche e sociali della più celebre ossatura Dom-Ino di Le Corbusier e Max Du Bois. Senza che vi sia ancora l’idea di temporalità aperta che caratterizza il concetto di «chantier permament» poi sviluppato da Huyghe, Le Corbusier aveva indicato i modi per sfruttare i pilastri e i solai in calcestruzzo armato ai fini di favorire un’autocostruzione economica e creativa. Anche lo «chantier permament» di Hyghe coinvolge idee e processi dell’architettura contemporanea: basti pensare a Alejandro Aravena e ai quartieri costruiti con Elemental nell’America Latina, ossature completate progressivamente dagli abitanti.
Tra i molti altri temi che tratti nei tuoi studi c’è quello del calco, che dall’arte tracima nell’architettura e viceversa.
È un tema che accomuna architetti e artisti: se pensiamo ai calchi in gesso dello spazio architettonico eseguiti da Luigi Moretti e pubblicati nella sua rivista «Spazio», ci rendiamo conto di come qualcosa di simile sia accaduto in A Cast of the Space Under My Chair (1968) di Bruce Nauman dove lo spazio invisibile è stato solidificato in un blocco di calcestruzzo. Rachel Whiteread si ispira a Cast of the Space… Però lei trasforma la dimensione astratta di quell’atto in un calco che vuole prima di tutto fissare una memoria. Nelle sue opere, come House (1993), il calcestruzzo porta tracce che rendono visibile la vita trascorsa in uno spazio e offre spunti decisivi ad architetti come Diener & Diener, AFF o Brandlhuber per riconsiderare l’uso convenzionale del materiale edile e farne l’ingrediente decisivo di un processo che conduce a creare calchi di memorie e non più soltanto impronte della tecnica.
Qui è possibile acquistare Archi 3/2020. Qui si può invece leggere l'editoriale con l'indice del numero.