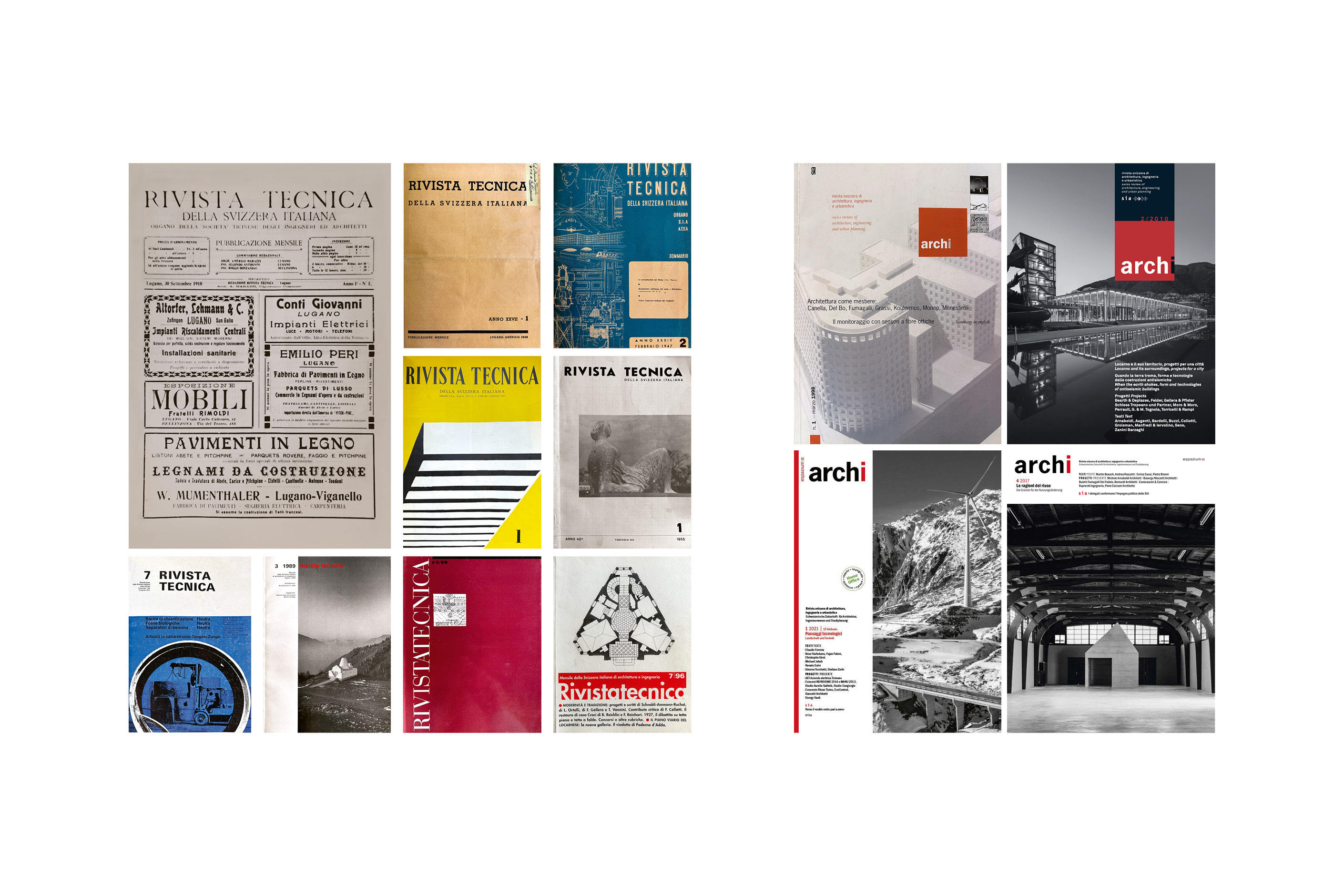Architettura in fiamme
Dal mito di Prometeo alle installazioni della Biennale di Venezia, il fuoco continua a bruciare nell’immaginario e nell’architettura: alleato e nemico, simbolo di protezione e distruzione, tra rituali, provocazioni artistiche e memorie collettive.
Di psicanalisi del fuoco scriveva Gaston Bachelard nel 1938, sottraendo tale elemento primordiale all’eccessiva frammentazione del sapere compiuta dalla scienza novecentesca, per riportarlo al centro dell’immaginazione umana e delle sue pulsioni più profonde. Per Bachelard, il fuoco è infatti desiderio, sogno, fantasia, calore domestico, eros, volontà di conoscenza, memoria e molto altro, e come tale andava affrontato, in un’analisi della metafisica dell’immaginazione che in questo caso comprende il complesso di Prometeo, di Empedocle, Novalis, e molto altro.
Tracce della filosofia di quel libro sembrano risuonare – in termini questa volta architettonici – in un’installazione del Padiglione della Polonia alla Biennale di Venezia 2025. In una nicchia scavata nella parete, con al centro una decorazione di conchiglie su sfondo di pietruzze, stelle marine e raggi stilizzati, ci aspetteremmo la nascita di Venere dall’acqua e invece troviamo un banalissimo estintore rosso fuoco, di cui immediatamente non capiamo il senso.
La provocatoria allegoria è parte di un ragionamento sul carattere protettivo che l’architettura ha sempre avuto per l’essere umano, dialogando con ansie ataviche e pericoli quotidiani che trasformano gli strumenti della sicurezza in dispositivi apotropaici, al di là della loro specifica funzione. Così, come Lari e Penati, le divinità protettrici della casa nell’Antica Roma, anche l’estintore (e con lui i segnali di emergenza, videocamere di sicurezza, serrature, ecc.) si merita il suo altarino.
L’idea di trasformare l’estintore da oggetto incomodo (ma necessario) dello spazio museale a opera d’arte non è nuova: nel 1976 l’artista Dove Bradshaw scelse un fire hose del Metropolitan Museum di New York e ci attaccò di fianco una didascalia. Ne fece poi scattare una fotografia (oggi parte delle collezioni del museo) e distribuì delle copie tra le cartoline in vendita, immettendosi così nel ciclo consumistico dell’arte.
Un parallelo ancora più stimolante si rintraccia in un’altra installazione architettonica, creata all’Università di Graz nel 1980 dai viennesi Coop Himmelb(l)au. Dopo anni passati a progettare strutture simili a nuvole, scelsero di collocare una struttura di metallo alta 15 metri nel cortile della scuola, irrorandola di benzina e appiccando il fuoco alle 8:35 di sera del 12 dicembre. Potenti altoparlanti amplificarono il crepitio delle fiamme e l’esplosione dei vetri messi a protezione, dando vita a un rituale collettivo che all’epoca poteva ricordare i falò delle chitarre di Jimi Hendrix e le sedie in fiamme di Alessandro Mendini. «L’architettura deve ardere», ribadiva il gruppo, sognando la nascita di un’inedita bellezza architettonica più legata a Efesto che ad Afrodite.
Su fuoco e architettura potremmo continuare a lungo, dato che l’uno è fin dalla notte dei tempi prezioso alleato dell’altra, ma pure la sua nemesi terribile. Se il focolare è origine e simbolo della casa, e il camino (prima della televisione) il suo centro spaziale (vedi Frank Lloyd Wright), gli incendi furono e rimangono uno dei flagelli per la storia della città, da quello di Roma nel 64 d.C. ai Great Fires di Londra (1666) e di Chicago (1871), fino a recenti tragedie come la Grenfell Tower e i roghi in California del gennaio 2025. Come sappiamo, molte di quelle sciagure hanno avuto forti conseguenze sul nostro modo di costruire: dall’uso mattone al posto del legno alla nascita del grattacielo per sfruttare al massimo la tabula rasa lasciata dalle fiamme. Per le disgrazie più recenti, staremo a vedere. Nel frattempo, continuiamo a esorcizzare il fuoco, in ogni modo: dal 2000, ogni anno, in occasione del Burning Man Festival una instant city prende forma nel deserto del Nevada, celebrando questo atto fondativo dando alle fiamme il Tempio, costruzione effimera che ricorda, anche, la caducità dell’architettura.