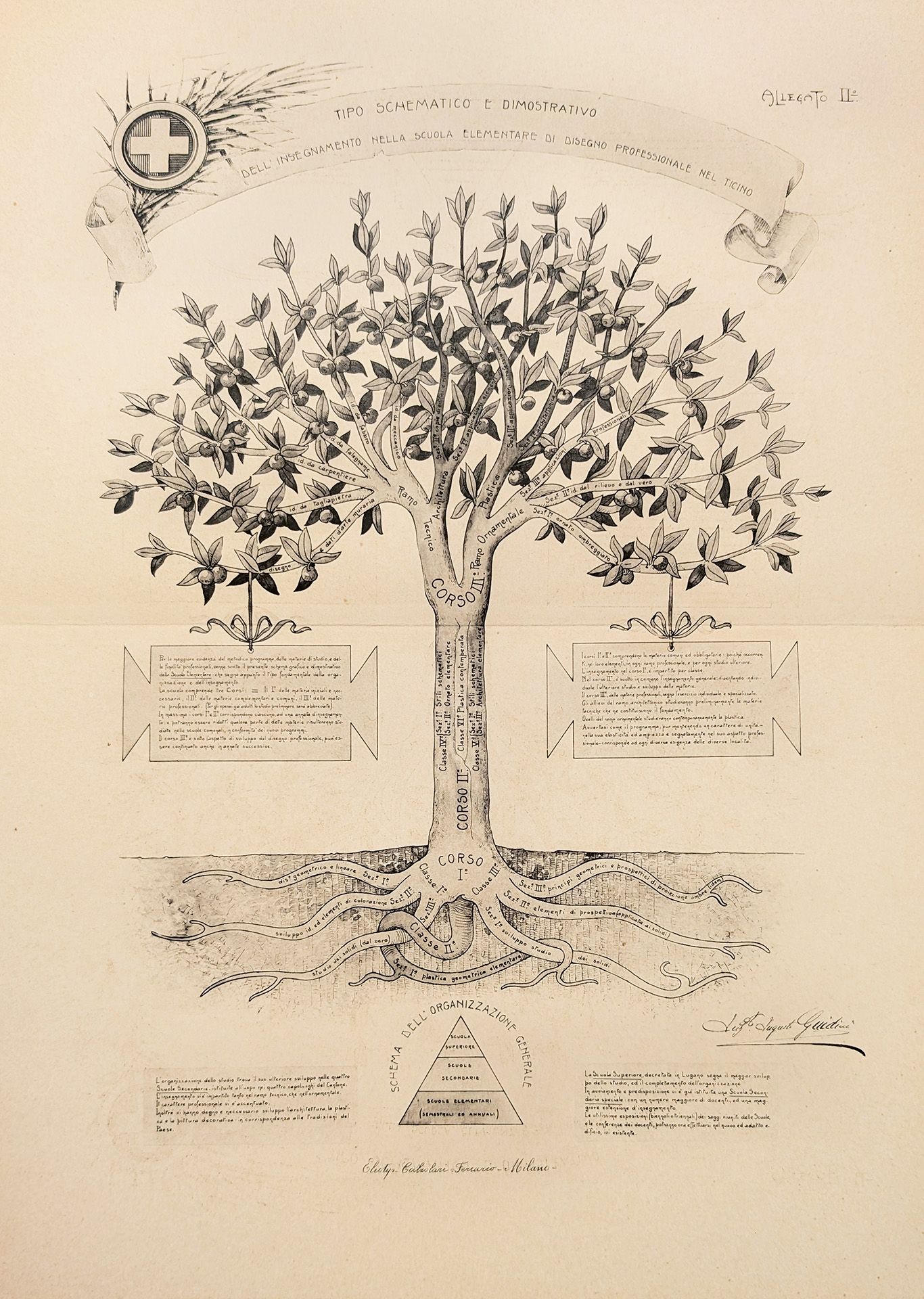Carattere e caratteri della scuola
Il riverbero della tradizione
Cosa definisce oggi il carattere di una scuola? Questo saggio esplora l'evoluzione della tradizione architettonica scolastica in Ticino e in Alto Adige, ripercorrendone le radici, le tensioni e le continuità tipologiche attraverso progetti esemplari e interviste ad architetti di spicco.
Character and characters of the school. The resonance of tradition english version
«L’architettura delle scuole in Svizzera, come traduzione di un tema fondamentale per un popolo votato al progresso civile, ha dato e continua a proporre risoluzioni di grande interesse».1 Con questa chiara affermazione Giorgio Grassi nel 1962 cominciava il suo articolo sull’architettura scolastica svizzera dalle pagine del numero 266 di «Casabella - Continuità». Attraverso l’analisi di due progetti esemplari di scuole, il breve saggio dimostrava la corrispondenza del valore della funzione e della forma dell’architettura scolastica, ricordando come il grado di maturità di conoscenza storica di un tema di architettura, sia alla base della possibilità di sperimentazione e originalità della forma architettonica.
Rileggendole a distanza di più di mezzo secolo ci si potrebbe chiedere se tutto questo sia ancora valido oggi; se quel continuo processo di «traduzione» si sia trasformato nel tempo in una tradizione, che opera come sottofondo dei nuovi progetti. Io credo di sì. A dimostrazione di questo basterebbero le numerose pubblicazioni che negli ultimi anni hanno raccontato e indagato il periodo eroico della sperimentazione architettonica svizzera, che specialmente in Ticino tra gli anni Sessanta e Ottanta ha messo in opera un repertorio di «architetture per diversi aspetti esemplari sia per la straordinaria qualità funzionale, spaziale, strutturale costruttiva, sia per le capacità di interpretare e declinare nuove e più aggiornate istanze pedagogiche».2
Ogni tradizione pone però una questione fondamentale come ricorda Elémire Zolla: «La Tradizione è la trasmissione dell’idea dell’essere nella sua perfezione massima, dunque di una gerarchia tra gli esseri relativi e storici fondata sul loro grado distanza da quel punto o unità».3 Vale a dire che non è nella somiglianza formale, specialmente linguistica, che va ritrovato l’elemento decisivo in cui riconoscere la continuità di una tradizione, ma nella tensione verso un comune destino, che lega tra loro opere e linguaggi di tempi e occasioni diverse in una grande opera, che assume nel tempo i tratti di un carattere distintivo, attraverso i caratteri di ciascuna di esse.
La recente spinta di produzione e rinnovamento delle architetture scolastiche in Ticino ci aiuta per quantità e qualità ad illuminare i segni di una «possibile» tradizione rispetto all’edilizia scolastica della «grande palestra» degli architetti ticinesi degli anni Sessanta-Ottanta, per usare la eloquente espressione di Bruno Reichlin. Se già nel numero 2/2022 di Archi «Architettura scolastica in Ticino»4 si è tentato di stabilire i punti di connessione e discontinuità di questa tradizione tesa tra gli anni Cinquanta e le recenti realizzazioni, riscontrando però alcuni decisivi cambiamenti nelle ragioni costitutive e nelle relazioni rispetto al mondo dell’architettura,5 in questo numero si è pensato di indagare la vitalità di una tradizione, mettendola a confronto con un’altra analoga per caratteri geografici, vale a dire quella dell’Alto Adige, punto di riferimento della critica architettonica per i virtuosi processi di ripensamento della scuola che trovano espressione nel linguaggio dell’architettura.6
Attraverso un’intervista doppia a Sandy Attia e Matteo Scagnol (MoDusArchitects) e a Sandra Giraudi (Giraudi Radczuweit architetti), due studi con una forte esperienza nel rinnovamento della scuola, si è cercato di delineare un panorama sul tema tra l’architettura dell’Alto Adige e quella del Cantone Ticino, due realtà con forti caratteri identitari che l’architettura sembra esprimere con evidenza nella continuità dei migliori progetti, sempre esiti di percorsi di progettazione concorsuali. Entrambe le regioni hanno inoltre accolto negli ultimi decenni un forte rinnovamento della normativa scolastica, che ha riformato, a volte rivoluzionato, il tema dell’architettura della scuola di ogni ordine e grado, attraverso un cambio di prospettiva rispetto al ruolo del «progetto» pedagogico. Questa intervista si concentra su alcuni aspetti fondanti del progetto – il tema, la pedagogia, la normativa – e sui momenti decisivi del suo sviluppo verso la realtà costruita – il concorso, il luogo, la costruzione –, mostrando alcune assonanze e criticità.
Dal punto di vista dell’esperienza progettuale entrambi gli studi rimarcano la necessità di ogni progetto di stabilire, ma soprattutto trovare, dalla concezione alla realizzazione, un dialogo profondo con il luogo e con il tema pedagogico, preformato dalla comunità ed espresso dai direttori scolastici. Se il concorso è inteso da entrambi come il necessario laboratorio per una originale e sperimentale idea architettonica, le fasi di sviluppo sono il terreno nel quale trovare le sue fondamenta attraverso un confronto concreto e partecipato con le altre discipline, sempre nel segno però di un reciproco riconoscimento dei limiti delle competenze disciplinari, come ricorda Sandy Attia assieme alla pedagogista Beate Weiland nella ormai fondamentale pubblicazione Progettare Scuole, tra pedagogia e architettura: «Quanto più ciascun istituto scolastico costruisce un profilo pedagogico e didattico originale (…) tanto più questo può trovare riscontro nell’architettura che lo informa».7 Emerge anche un comune e ritrovato interesse in una ricerca di specificità tipologica, basata sulle condizioni singolari del progetto piuttosto che sul suo senso di astrazione verso la generalità, che trova ogni volta le più significative relazioni tra l’unità base dell’aula didattica e gli spazi di supporto e distribuzione, considerati sempre più importanti nelle concezioni pedagogiche e allo stesso tempo sempre in cerca di una forma autentica.
Dall’altro lato Attia e Giraudi, che godono di una consistente presenza nelle giurie di concorso che permette loro di restituire un panorama critico rispetto alla produzione progettuale contemporanea e alle condizioni di salute dell’architettura, sollevano un preoccupante paradosso. La grande quantità di occasioni di concorso sospinte dalla pressione di una domanda di innovazione, sembra produrre per inverso un riprodursi dell’identico,8 una omologazione delle proposte progettuali che si appiattiscono nella risposta efficiente a una domanda troppo spesso giustificata da istanze tecnologiche, economiche o gestionali, che poco restituiscono al tempo dell’immaginazione progettuale del senso e della sua eloquenza formale come osserva Sandra Giraudi: «Un’idea di scuola credo che fatichi a rinnovarsi, nascondendosi dietro l’attenzione alle tematiche ambientali, che invece di stimolare l’innovazione vengono usate come giustificazione per soluzioni efficienti ma standardizzate e ripetitive, senza dialogo con il luogo e la comunità, al punto che mi chiedo se siano architetture pensate per l’uomo. Il punto è quindi interrogarci sulla cultura che alimenta il tema della Scuola e quali sono i caratteri del rinnovamento».
I progetti raccolti in queste pagine raccontano invece la varietà e possibilità delle diverse occasioni cui i progettisti, sono chiamati a dare oggi risposta. Questi progetti sono accomunati dalla necessità di stabilire un radicamento con una condizione di luogo preesistente, in cui la necessità del rinnovamento diviene un’opportunità per il ripensamento del senso del luogo in relazione al contesto naturale e urbano. I nove progetti presentati nascono tutti da un confronto con le preesistenze architettoniche e ambientali, attraverso demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, quindi per loro stessa ragion d’essere legati a un senso di continuità o discontinuità con il passato.
Il nuovo complesso scolastico per San Vittore di Moro & Moro è l’unico «ex-novo» e forse per questo l’unico caratterizzato da una riflessione tipologica sul ruolo di «cittadella» che può assumere una piccola scuola all’interno di un territorio di valle, interpretata attraverso un impianto sviluppato attorno all’internità di un grande patio, costituito però da tre edifici autonomi a blocco compatto giuntati tra loro da portici. Altri progetti invece si inseriscono in condizioni esistenti cercando di ritrovare un valore da far emergere attraverso la ricomposizione dello spazio permessa dall’aggiunta del nuovo. Nell’intervento di Beier Cabrini un lungo blocco in linea media le differenze altimetriche con il muro di sostegno di un cimitero, rappresentando con la quinta di un muro abitato il fondale del nuovo parco su cui si affaccia l’intera scuola. Un’analoga soluzione compositiva è utilizzata da Bonetti Architetti per restituire un ordine e una rappresentatività civile ai campi rionali all’interno di un denso tessuto abitato, attraverso il corretto posizionamento di un edificio a blocco in linea, in questo caso però caratterizzato da una tipologia passante e attraversabile, che costruisce due affacci analoghi sul giardino della scuola e sulla piazza dei campi rionali.
Il tipo passante con aule intervallate da blocchi distributivi di atri risalite e servizi è uno dei modelli più utilizzati per conferire un doppio rapporto agli edifici relativamente piccoli delle scuole dell’infanzia. Nella scuola di Lamone di KSM l’impianto a blocco in linea passante ridefinisce l’area della vecchia scuola demolita liberando lo spazio interno a giardino pedagogico e costruendo su strada uno spazio per l’accesso, dove il tema dell’edifico-filtro alimenta il linguaggio della costruzione sopraelevando un volume in calcestruzzo armato di vuoti e pieni decorati a losanga, sopra il vuoto trasparente dello spazio aperto alle relazioni.
Un’altra categoria di progetti sono gli ampliamenti di scuole esistenti, dove i progettisti del nuovo aprono un confronto diretto con il riconoscimento dei valori di novità e persistenza di una tradizione di architettura scolastica. I due interventi di ampliamento di Inches Geleta e Cappelletti Sestito ne sono un esempio attraverso la soluzione insediativa a padiglione, quindi costruttivamente e funzionalmente autonoma. I primi stabiliscono un radicamento dell’edificio a padiglione passante, inserendolo nel pendio del suolo con un basamento su cui sono sollevate le aule, costruendo l’immagine a distanza di una sostruzione, che radica e tiene assieme l’intero complesso scolastico alla collina su cui si insedia. Il progetto di Locarno invece, attraverso la logica posizionale del nuovo padiglione, realizza una quinta per il parco delle scuole progettate nel 1973 da Dolf Schnebli che, sempre attraverso un tipo passante a due piani con portico in arretramento, funziona da soglia di accesso e fronte rappresentativo del complesso.
Il dialogo con la preesistenza si fa ancora più stretto nei progetti di Boltas Bianchi a Cadro e Baserga Mozzetti a Manno, arrivando al punto di contatto nella costruzione dell’ampliamento. Nel progetto di ampliamento con Scuola dell’Infanzia di Cadro i primi recuperano i caratteri costruttivi e tipologici dalla scuola esistente impostata su una corte, che viene rinforzata con il prolungamento di una sua ala reinterpretandone il linguaggio, e poi ampliata recuperando l’idea di corte aperta della scuola elementare, rispecchiandola sul retro per costruire il giardino più protetto della scuola di infanzia.
Baserga Mozzetti sono protagonisti infine di due progetti, diversi per occasione, ma accomunati ambedue dalla sensibilità nel saper leggere le criticità e qualità dell’esistente, conservandole e valorizzandole, con l’inserimento del nuovo. Nell’ampliamento della Scuola di Manno la nuova elegante struttura del padiglione ad aula, con tetto a lastra sollevato su forcelle, reinterpreta e avvalora il carattere aperto e sperimentale della scuola di Pellegrini realizzata nel 1970 attraverso un posizionamento speculare. Il progetto per la ristrutturazione della scuola di Vezia è invece un piccolo saggio di cosa un architetto deve saper vedere, prima ancora di progettare un intervento che valorizza ciò che c’è al punto da mostrarsi come se ci fosse sempre stato.
Ecco che il tema del rapporto con la storia e la costruzione di una tradizione si mostrano in casi come questo - più specifici e solo apparentemente più tecnici - come la vera soluzione per l’immaginazione del nuovo.
Per riprendere le parole di Carlo Olmo, una scuola di Architettura, ma più in generale un progetto di architettura, dovrebbe partire dal «recuperare il valore della storia, perché solo così si può misurare l’innovazione».9 La sola domanda tecnica, la sola informazione, la sola rispondenza ai dati offrono risposte che non sono insignificanti ma non è detto che siano significative. In assenza di riferimenti si procede sì, ma senza direzione. Il pluricitato libro di Alfred Roth New Schools 10 ha avuto un destino felice perché ha fornito casi esemplari di architettura accomunati da uno spirito comune. Sono riferimenti con cui misurare il progetto del nuovo, con cui innescare un confronto, con cui stabilire la tensione verso un orizzonte di senso da raggiungere appoggiandosi ad essi, ma trasgredendoli con coraggio e consapevolezza.
E allora, riscoprire il continuo ripresentarsi e rinnovarsi del carattere dell’architettura della scuola nei caratteri delle architetture scolastiche, non ci permette in fondo di riflettere proprio su questo?
1. G. Grassi, L’edilizia scolastica in Svizzera e la scuola come esperimento, «Casabella», 266, agosto 1962.
2. M. Iannello, Architettura e pedagogia. Cantone Ticino 1945-1980, «Archi», 2/2022, p. 31.
3. E. Zolla, Che cos’è la tradizione, Adelphi, Milano 1998, p. 134.
4. Architettura scolastica in Ticino, a cura di F. Belloni e G. Zannone Milan, «Archi», 2/2022.
5. «Tra la prima e la seconda metà del Novecento, l’affermazione del primato dell’architettura moderna (forma, linguaggio, estetica ecc) aveva trovato il suo principale campo di interesse e applicazione nell’edilizia scolastica (…). Oggi, viceversa, in molti casi sembra evidente il rischio del contrario; sembra cioè che la ragione architettonica che guida i progetti si stia facendo derivare dai vincoli tecnici o dalla mera trascrizione delle tendenze pedagogiche, condizione che porterebbe a perdere di vista la riflessione sul rapporto tra edificio, città e territorio» Cfr. F. Belloni, Cosa vuol esser la Scuola? Note sula nuova provincia pedagogica, ivi. p. 24.
6. Dell’argomento si è occupata con continuità la rivista alto atesina «Turris Babel». Cfr. Costruire Pedagogie/für Bildung bauen, «Turris Babel», 93, 2013; Zurück in die Schule/Ritorno a scuola, «Turris Babel», n. 119, 2020.
7. B.Weiland, S.Attia, Progettare scuole tra pedagogia e architettura, Guerrini Scientifica, Milano 2015, p. 15.
8. «Può darsi che l’inquietudine iperattiva, l’attività febbrile e l’irrequietezza correnti non giovino al pensiero e che questo, per la crescente pressione temporale, non faccia altro, allora, che riprodurre l’identico. (…) La generale pressione del tempo annienta ciò che devia ed è indiretto. In questo modo, il mondo diventa povero di forme» . Cfr. B-C.Han, Duft De Zeit. Sin philosophischer Essay zur Kunst des Verweilens, 2009. Il profumo del tempo, Vita e Pensiero, Milano 2017. pp. 125-126.
9. A. Roth, The New School / Das Neue Schulhaus / La Nouvelle Ecole, Girsberger, Zürich 1961.
10. C. Olmo, Tornare a Thoreau e Monge, «Archi», 2/2022. pp. 16-17.