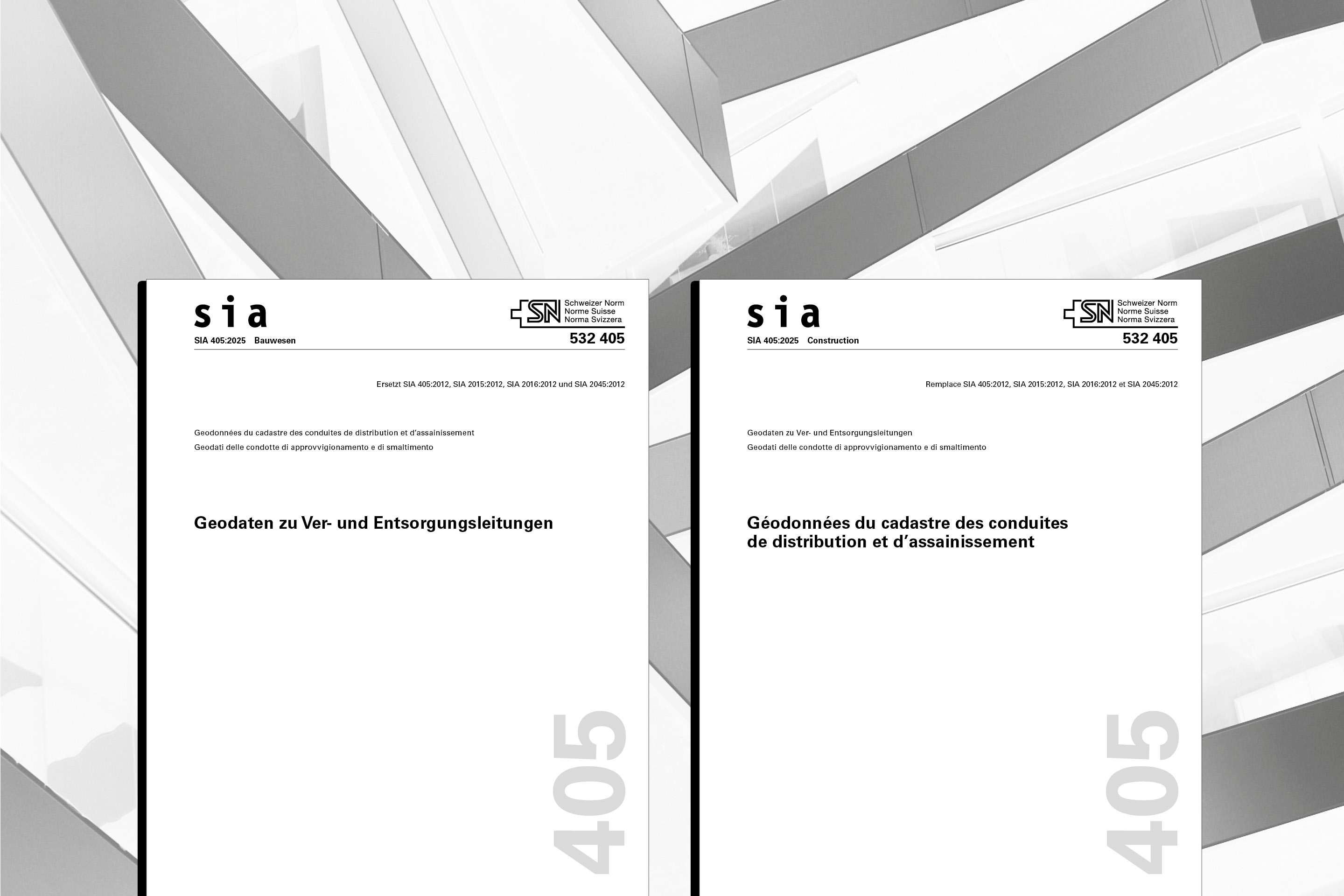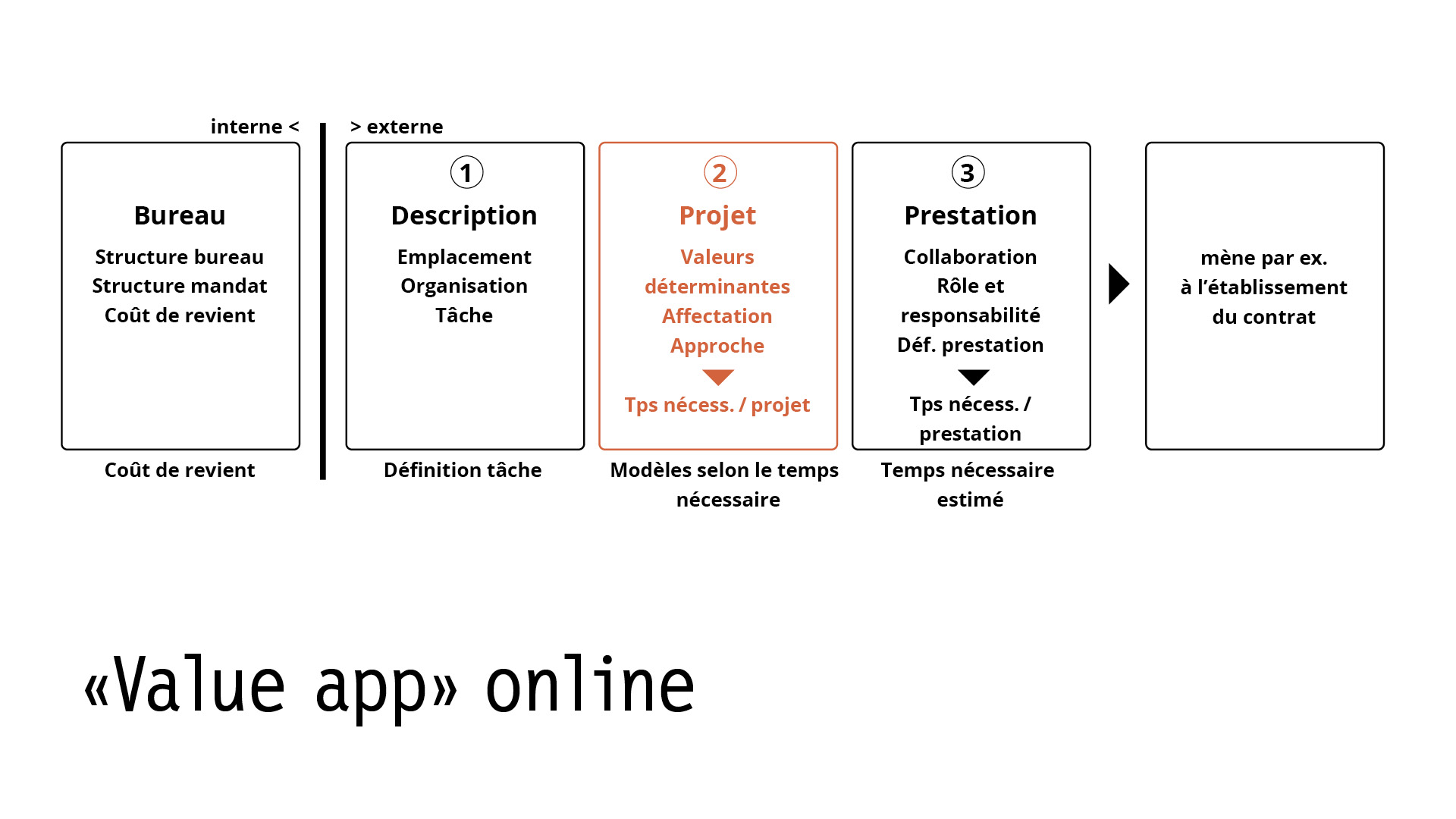Rigenerare la memoria industriale: nuovi scenari per il Ticino
Negli spazi di SUPSI Mendrisio, il VII seminario SIA Ticino, in collaborazione con la Società per l’arte dell’ingegneria, ha esplorato le potenzialità di rigenerazione del patrimonio industriale come risorsa progettuale e culturale per il futuro del Cantone. Un dialogo interdisciplinare tra architettura, ingegneria e memoria collettiva.
Quali strumenti di tutela per il patrimonio industriale degli ultimi secoli?
Quale futuro per il patrimonio industriale che stiamo generando oggi?
È a questi e ad altri interrogativi che è stato dedicato il VII seminario di studio organizzato da SIA sezione Ticino in collaborazione con la Società per l’arte dell’ingegneria, tenutosi negli spazi della SUPSI di Mendrisio Dipartimento ambiente costruzioni e design, dal titolo “Rivitalizzazione del patrimonio industriale per nuovi scenari urbani”.
Un momento di dialogo a più voci volto alla sensibilizzazione collettiva verso le espressioni architettoniche e ingegneristiche che testimoniano la storia economica e culturale del Canton Ticino.
Ad aprire l’evento, dopo i saluti istituzionali di Francesco Piatti ed Enrico Rossi, rispettivamente rappresentanti di SIA Ticino e SUPSI, è stato l’intervento di Valeria Frei, storica dell’arte e dell’architettura, che ha presentato al pubblico un frame storico volto a una riflessione sulle potenzialità culturali della conservazione e promozione delle grandi “cattedrali industriali” che costellano il paesaggio alpino del Cantone. L’intervento è stato condotto a partire dalle ricerche confluite nella recente pubblicazione Ticino industriale. Una guida architettonica edita da Casagrande, che propone un itinerario culturale e storico per riallacciare un legame con il contesto produttivo e industriale che ha posto le basi per il nostro presente.
Nel secondo panel, Aurelio Muttoni ha riletto il tema spostando il focus sull’ingegneria, attraverso il caso studio del ponte di Frasco sulla Verzasca: a partire da alcune fotografie ritrovate tra i ricordi di famiglia, lo sguardo si è focalizzato sul ruolo dell’ingegneria e della sua conservazione nel tempo, per comprendere come intervenire in modo coerente sulle esigenze di risanamento e adattamento di queste strutture, o come nel caso studio presentato, come trovare un equilibrio tra un nuovo intervento che risponda alle necessità infrastrutturali del presente e la volontà di conservare e preservare l’importante patrimonio ingegneristico e storico locale.
Sara Rossi ha arricchito il panel con un racconto che riporta queste infrastrutture alla loro dimensione sociale e umana, attraverso la lettura del “Quaderno della Monteforno. Un racconto di fabbrica”, dove emerge l’attaccamento allo stabilimento da parte della fascia operaia e l’ecosistema sociale che si struttura nel suo immediato intorno.
La seconda parte del palinsesto ha visto l’intervento di Gilbert Moro e Barbara Berger, che hanno presentato al pubblico il caso del patrimonio storico delle FFS e le sfide di una conservazione attenta delle infrastrutture: un patrimonio che, attraverso espressioni architettoniche e ingegneristiche di pregio - nella realizzazione di stazioni, ponti ferroviari, officine e linee ormai dismesse - è ancora capace di raccontare la storia della mobilità e del progresso tecnologico a essa legato.
Letti in una logica non solo di conservazione ma anche e soprattutto di ri generazione, i casi studio presentati costituiscono il punto di partenza per un approccio di lettura del passato in chiave di integrazione attiva nel contesto urbano, nella prospettiva di una conversione di questi ampi spazi in nuovi dispositivi culturali.
L’intervento di Giotto Messi per Schnetzer Puskas ha riportato poi il discorso su realizzazioni più recenti di recupero dell’esistente, ripercorrendo gli aspetti ingegneristici più salienti e contribuendo a un ribilanciamento del dibattito tra passato e presente.
In chiusura, lo studio Camponovo Baumgartner ha presentato progetti di rivalorizzazione e riconversione del patrimonio industriale, illustrando le potenzialità di una reintegrazione dell’esistente nel contesto urbano contemporaneo.
A emergere dal seminario è stata una visione condivisa: il patrimonio industriale non è soltanto una traccia del passato, ma una risorsa progettuale e culturale per immaginare nuovi scenari urbani. La sua tutela e la sua rigenerazione richiedono oggi una collaborazione sempre più stretta tra discipline - dall’architettura all’ingegneria, fino alle scienze sociali - affinché gli spazi della produzione diventino luoghi di memoria viva, capaci di generare nuove forme di abitabilità, cultura e identità collettiva.