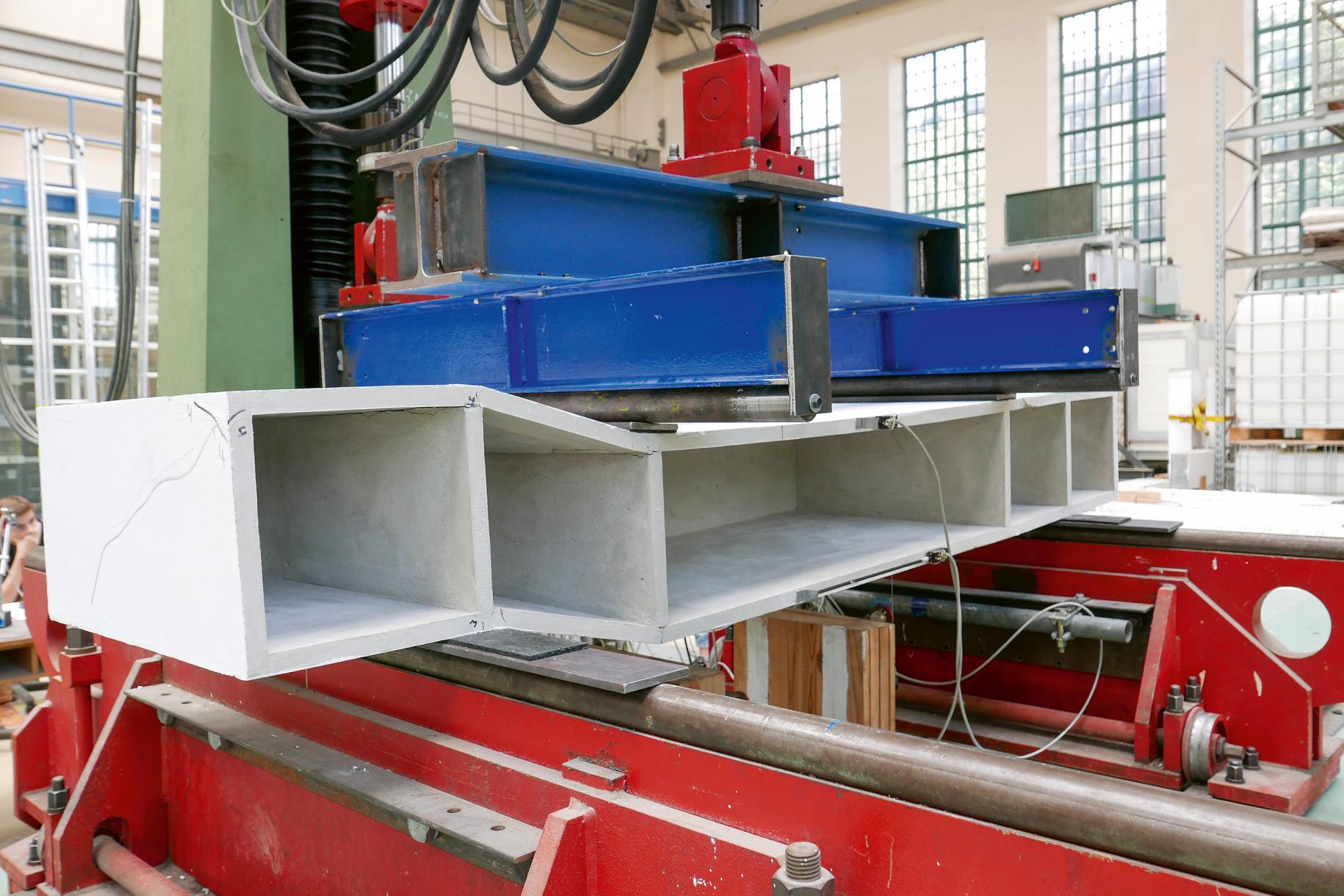Prendersi il tempo
Per rendere l'architettura un’attività sostenibile occorre prendersi il tempo necessario per progettare. È quanto sostiene l’architetto indiano Anupama Kundoo, il cui lavoro trentennale svolto ad Auroville, in India, è esposto quest’anno presso il Louisiana Museum of Modern Art nell’ambito della mostra Taking Time. Attraverso il suo manifesto, l’architetto definisce un nuovo modo di pensare e costruire.
L’architettura richiede tempo. Non solo gli edifici sopravvivono all’uomo, ma la creazione delle città e dei monumenti dura vite intere, continuando di generazione in generazione. Per avere senso, l’architettura dev’essere in grado di resistere alla prova del tempo. Deve basarsi su una riflessione a lungo termine, prendendo spunto dalle costruzioni del passato e agendo nel presente, con in mente una visione del futuro della società. Possiamo prolungare la vita dei nostri avi elaborando visioni sempre pertinenti, anziché riscoprire l’acqua calda in ogni nuovo progetto, come se l’architettura dovesse ripartire da zero. Come architetti contemporanei, siamo disposti a lavorare su concetti elaborati dai nostri predecessori qualora si rivelassero utili?
Fin dai tempi dell'industrializzazione si tende a considerare che “il tempo è denaro”. I cittadini non hanno tempo e di conseguenza non possono prenderselo per dedicarsi in prima persona alla produzione di ciò di cui hanno bisogno e per compensare i costi delle loro case, come facevano invece gli abitanti delle campagne... Molti dei problemi attuali derivano da questo assunto sbagliato. Oggi partiamo dal presupposto che se fosse possibile ridurre il tempo che ogni essere umano deve dedicare a fare qualcosa saremmo tutti più efficienti. Tuttavia, questa corsa all’efficienza porta a trascurare la condizione dell’essere umano, non curandosi di sapere se la società sta andando bene o meno. La standardizzazione e la produzione di massa hanno portato a sottovalutare le capacità umane, come l'intuizione, l'intelligenza emotiva e il giudizio personale. Nonostante tutte le comodità e gli incrementi di efficienza ottenuti, la vita contemporanea è fortemente caratterizzata da stress e frenesia. Per risparmiare tempo, abbiamo delegato molte cose alle macchine e aumentato notevolmente la produzione e il consumo di risorse, senza però riuscire ad avere più tempo per noi.
Pur con tutti i progressi tecnologici di cui dispone, l’architettura contemporanea consuma molte più risorse di quanto non facesse prima. Ma dovremmo chiederci: le città sono più belle? E noi, siamo più felici? La sostenibilità, una delle principali preoccupazioni della nostra epoca, è intrinsecamente legata al tempo, poiché deve soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro. Non si tratta solo di tecnologie e materiali impiegati nella costruzione architettonica, ma anche della validità e della pertinenza delle idee contemporanee sul lungo periodo.
La rapida urbanizzazione attuale, con i tanti grattacieli che spuntano in tutto il mondo a una velocità impressionante, sta ridefinendo la forma degli insediamenti umani: costruzioni urbane ad alto consumo, in cui si intrecciano insediamenti informali e segregazione sociale ed economica. La mercificazione delle abitazioni e la loro inaccessibilità rendono necessari approcci alternativi, in particolare la considerazione della nozione temporale da parte dei futuri residenti nel modo in cui l’architettura viene realizzata e finanziata, affinché le abitazioni possano tornare ad essere percepite come uno spazio abitativo anziché come un investimento che genera debiti. L'impiego di risorse umane come il tempo, l'intelligenza, la forza muscolare e l'impegno diretto possono ridurre il dispendio di risorse naturali, creando al contempo salute, benessere e felicità.
Il braccio di ferro tra quello che chiamiamo progresso e il rapido degrado ambientale genera un senso di urgenza e di panico. Invece di rispondervi con azioni altrettanto affrettate, dobbiamo prenderci il tempo necessario per pensare prima di agire e investirci pienamente, perché potremmo aver bisogno di ripensare radicalmente il nostro futuro per creare nuove abitudini funzionali ai nostri obiettivi. Non possiamo più permetterci di pensare a breve termine, a vantaggio di una minoranza; la fretta non fa altro che aumentare il nostro ritardo.
Poco dopo aver conseguito la laurea in architettura a Bombay, consapevole di queste preoccupazioni, ho deciso di prendermi del tempo per fare chiarezza sull’evoluzione della mia vita, sia come persona che come architetto, e su come poter essere al servizio della società sentendomi realizzata. Le mie peregrinazioni mi hanno portata nella regione rurale del Tamil Nadu, in India, dove ho scoperto Auroville, una città internazionale in fieri. Ho deciso spontaneamente di prendere parte a quest’avventura e ho cominciato a viverci, avendo intravisto un’opportunità affascinante di ripensare la città del futuro, dove l'habitat umano potesse essere riorientato in modo olistico come parte di un'esperienza collettiva.
La decisione temeraria di lasciare Bombay mi ha finalmente permesso di passare molto tempo a non fare nulla e a riflettere su ciò che vale veramente la pena fare, rendendomi conto che il tempo era il lusso più grande, sia per i ricchi che per i poveri. Noi architetti svolgiamo un’attività che rientra in una grande azione collettiva spazio-temporale: ci basiamo sul lavoro delle generazioni precedenti in un continuo movimento evolutivo che non inizia con la nostra esistenza personale. La comprensione di ciò porta a un processo in cui costruiamo conoscenze mentre creiamo e rivela le potenzialità dell’architettura nell'impegnarsi a svolgere l’arduo compito di mettere insieme urbanizzazione, persone, tecnologie, risorse e ambiente. La mia pratica, frutto della mia ricerca dei concetti necessari per costruire in modo adeguato, considera ogni progetto come un’opportunità per creare conoscenze e un senso di comunità, in modo da consentire alle persone di realizzare spazi altamente qualitativi dal punto di vista estetico e a basso impatto ambientale.
Ho cominciato ad osservare il mondo attraverso la prospettiva del tempo, il passare del quale lascia un'impronta nel nostro ambiente. Le costruzioni architettoniche esistono da prima della comparsa dell’uomo. Assistiamo da sempre all'evoluzione della materia, della forma, dello spazio e dell’ordine: dalle rocce sedimentarie alla lava vulcanica, dalle formazioni di ghiaccio alle rocce modellate dall’azione erosiva dell’acqua. L’architettura più antica è forse proprio la trasformazione della materia nel corso dei tempi.
C’è poi l'impronta del tempo sull'architettura della vita stessa, che plasma la materia attraverso un’altra programmazione contenuta nel DNA delle cellule. L’architettura della vita si esprime attraverso un ordine e una geometria complessi, dove forma, spazio, luce ed elementi chiave del pensiero architettonico formano una sintesi sulla base di principi strutturali. Le strutture degli alberi e dei fiori, o dei funghi e delle conchiglie, le reti delle arterie e delle vene, degli animali o delle foglie, i nidi di uccelli, i termitai, gli alveari e le ragnatele continuano ad ispirare l’architettura delle abitazioni umane.
Va inoltre citata l’architettura della mente, con l’evoluzione del pensiero e della “mano pensante” che ha dato vita a strumenti sofisticati che hanno aperto nuovi orizzonti all’architettura. La costruzione di muri di terra si è evoluta grazie alla fabbricazione di stampi per produrre mattoni di adobe, che hanno a loro volta modellato la muratura, o, più tardi, grazie a forni che consentivano di cuocere moduli di argilla per produrre mattoni cotti.
Non è quindi solo il prodotto dell'architettura ma soprattutto il processo architettonico a costituire l’essenza stessa della forza viva, dinamica e intelligente che ingloba passato, presente e futuro. Tale processo rappresenta una forma di sintesi in grado di offrire risposte a tutta una serie di preoccupazioni attraverso un approccio olistico alla progettazione. Il tempo è la risorsa più importante di cui disponiamo come esseri viventi: non è forse l’unica cosa che possediamo veramente? Il tempo è vita, disponiamo tutti dello stesso numero di ore in un giorno, indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo e dalla nostra storia personale. Il tempo speso bene ci arricchisce molto più del denaro, ci permette di acquisire più conoscenze e ci soddisfa direttamente, mentre la vita stressante della città, che ormai accettiamo come normale, tende a farci perdere il contatto con noi stessi. Verrebbe da chiedersi se, con tutta l’attuale premura per risparmiare denaro e risorse, il tempo non sia una risorsa sottovalutata, spesa per abitudine piuttosto che in modo saggio e giudizioso, senza domandarsi se tali scelte siano effettivamente in linea con i nostri obiettivi.
Il senso della nostra esistenza dipende dal modo in cui la viviamo, non è una corsa. Invece di cercare di risparmiare tempo, dovremmo prenderci del tempo!
Anupama Kundoo è architetto. Ha realizzato la maggior parte dei suoi progetti in India e insegnato in varie università in tutto il mondo (Yale, AA, IUAV, ETSAB, ecc.). Oggi vive a Berlino e insegna alla Fachhochschule di Potsdam. Questo testo è stato tradotto e modificato dal manifesto “Taking Time” di Anupama Kundoo, pubblicato all'interno del catalogo della mostra esposta da ottobre 2020 a maggio 2021 al Louisiana Museum of Modern Art di Copenaghen.
Tradotto da Wulf Übersetzungen, Turgi