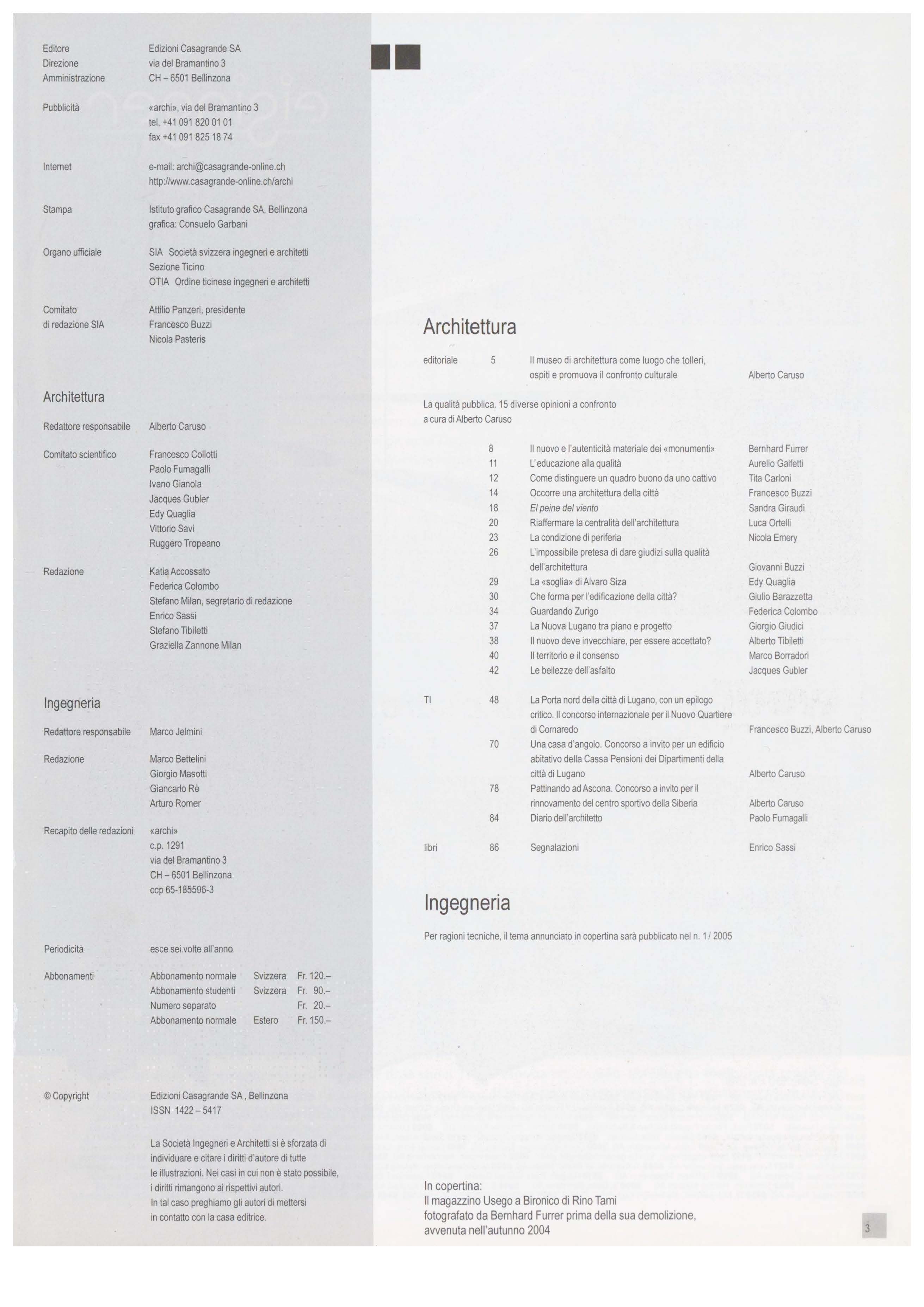Le bellezze dell’asfalto
Serie: I 20 anni di Archi (1998-2018)
Per i 20 anni di Archi, l'articolo di Jaques Gubler dal no. 6/2004. «Sarà il vecchio Piccolo Principe a ricordarci che il luogo iniziale dell’architettura pubblica si trova nella strada. Non è nella strada che i bambini imparano il mondo e gli architetti a costruire volumi e facciate sotto la luce?».
Premessa e nostalgia della biblioteca
Non vorrei proibire l’accesso alla biblioteca. Siamo aspettati da oltre mille libri e trattati. Forse una scorciatoia ci vuole, senza grandi deviazioni, per raggiungere il punto di partenza e la domanda posta da Alberto Caruso sulla «qualità pubblica» dell’architettura.
Il problema della qualità è legato all’esercizio del giudizio. Il giudizio estetico rimanda alla filosofia del bello. La parola estetica è un neologismo sapiente coniato nel 1750 dal filosofo di Francoforte A.G. Baumgarten. Dalla seconda metà del Settecento, in particolare in Germania (con Lessing, Kant, Hegel, Schopenhauer) l’estetica si sviluppa come sistema di spiegazione (totale o parziale) del mondo tramite l’opera d’arte. Questo non significa che il dibattito sul bello non esisteva prima della società industriale.
Claude Perrault, architetto, medico, filologo, dedica la sua traduzione francese di Vitruvio al Roi Soleil, Luigi xiv. Una nota del traduttore a pie di pagina definisce la bellezza architettonica (Perrault, Vitruve, 1, il, n. 13). Pubblicata nel 1684, questa nota è una dissertazione di 35 righe. Per Perrault, la bellezza contiene due elementi. Il primo, detto «positivo», segna empiricamente la presenza fisica dell’edificio nella città (programma istituzionale, solidità costruttiva, organizzazione funzionale della pianta). Il secondo si chiama «arbitrario». Cosa sarebbe la bellezza arbitraria! È la bellezza che si riferisce e si conforma al giudizio delle persone ritenute sapienti in materia d’architettura. Da questo momento entriamo nel terreno del gusto e dell’opinione. Che la bellezza sia arbitraria e relativa al consenso e al dissenso di un gruppo scelto di persone, è una delle prime scoperte della modernità. La seconda è che il consenso si oppone al dissenso per articolare una disputa. Il giudizio è il privilegio di una élite informata sulla teoria, la pratica e la complessità del mestiere: cosi suona il corollario aristocratico del postulato binario di Perrault. Il ruolo dell’Accademia è di dare credito alla verità dell’arte. Il concorso organizza l’emulazione qualitativa. La concorrenza è il motore delle arti liberali. Sembra che troviamo il nostro punto di partenza.
Cosa dice la biblioteca dei ragazzi?
Chi determina la bellezza dell’architettura pubblica? Proto democraticamente risponde Pinocchio: «La bella Bambina dai capelli turchini». D’altro canto Zazie, la ragazza impertinente nella metropoli democratica di Queneau apostrofa lo zio: «Non è il pubblico che fischia la bravura dell’arbitro?» Se l’architettura è spettacolo mediatizzato, allora sì, il pubblico può battere le mani e fischiare gli arbitri. Nell’età televisiva berlusconiana il gran gioco si incentra sulla domanda: «Dove sono le architetture da buttare?» Il gran gioco quotidiano della maggioranza rumorosa si chiama architettura da buttare. Litiga l’élite dello slowfood con la maggioranza condannata al fastfood. La demagogia televisiva spinge un jeune premier narcisista e storico della pittura alla sua discesa in campo. Il nostro si azzarda al kick off del partito della bellezza, mentre altri tromboni suonano l’idea di istituire il dittatore del bello o di riunire la commissione del buon gusto. Ci sono anche fedeli che pregano il san vescovo di tutelare il patrimonio. Per rimediare all’incuria dello spazio pubblico, altri auspicano il miracolo della privatizzazione degli edifici statali.
Il laissez-faire produce sulle strade numerose sorprese architettoniche sexy per vendere mobili, vestiti, patate fritte, caramelle. Forse in vent’anni «la gente» avrà avuto il tempo di digerire le cose triviali come fossero esistite da sempre. Finalmente la domanda «Chi determina la qualità dell’architettura pubblica?» diventa oziosa se si sceglie di rispondere che a decidere sono gli impresari e gli architetti play boy, amanti della bellezza soft. La disputa tra élite e qualunquismo porta ad uno stagno senza fondo.
Non vorrei riaprire il capitolo del dibattito estetico ormai vecchio di trent’anni che oppose il kitsch, (con)dannazione borghese del pessimo gusto, all’esperienza raffinata della pop art. Quindi la domanda iniziale del «Chi comanda?» sarà riformulata così: «Dove comincia la qualità dell’architettura pubblica?» Posso rispondere subito: nella strada. Sarà il vecchio Piccolo Principe a ricordarci che il luogo iniziale dell’architettura pubblica si trova nella strada. Non è nella strada che i bambini imparano il mondo e gli architetti a costruire volumi e facciate sotto la luce?
La strada, luogo primario dell’architettura pubblica
Mi ricordo il postulato dello Stadtwanderer (passeggiatore urbano) zurighese Benedikt Loderer: «L’uomo vede con i piedi». Sappiamo che lo stesso uomo vede anche con le gomme, persino quando guida con le pantofole. Mi ricordo per altro che, negli Stati Uniti all’inizio della presidenza di Ronald Reagan, la critica universitaria denunciò «la scomparsa del reame pubblico». I parchi urbani e gli edifici pubblici, in particolare le stazioni, lascito civile dell’Ottocento e del New Deal, eredità della politica dell’abbellire e della beauty applicata alla città, erano divenuti no man’s land pericolosi, sfruttati solo da gangs giovanili e dalla folla millepiedana dei senza tetto. La città di New York, abbellita da centinaia di parchi & giardini ne curava solo uno, in posizione centrale. Nel 1986 una squadra di tre persone poco pagate era responsabile della gestione & del mantenimento dei giardini pubblici new-yorkesi. È vero che in Europa siamo abituati a reputare che il Municipio gioca la sua rielezione sul piantare dei fiori, da Bilbao a Mendrisio, da Parigi ad Orléans. Esistono anche in Europa servizi pubblici per la raccolta delle siringhe vuote abbandonate nei parchi e sulle panchine.
Parlo di siringhe vuote per centrare la questione dell’arredo urbano. Siamo in media res. Seguendo Loderer sono convinto che l’architettura s’insegna con i piedi. Credo anche che le più belle opere d’arredo urbano sono il disegno industriale delle automobili e che la convivenza tra il corpo, il body work della vettura e le pantofole raccomandate al pedone sono possibili e desiderabili. Se la trasformazione dello spazio pubblico inizia nella strada, siamo indirizzati subito verso l’autostrada. Ripeto. Tra i temi i più difficili dell’architettura civile odierna troviamo la strada, l’autostrada, il parcheggio, il garage, il centro commerciale, la passerella sopra il traffico, la zona pedonale. Nelle scuole d’architettura fioriscono diplomi eleganti, «Una scuola di danza», «Il museo della tauromachia». Abbiamo bisogno di strade, parcheggi, passerelle.
Il programma della «zona pedonale» non è entusiasmante. Mai l’ho visto (per il momento) proposto o scelto nelle scuole che ho frequentato, vuoi per assenza di stimolo «artistico», vuoi per eccesso di realismo. La parola «zona pedonale» è molto brutta. Trova la sua origine nel compartimento ideologico della «città funzionale». Il fatto di chiamarla «riqualifica», come si dice a Chiasso, o «riqualificazione», come si dice a Roma o a Cerea presso Verona, sembra insistere sulla qualità ma non chiarisce la difficoltà del programma.
Da un quarto di secolo, la soppressione del traffico motorizzato all’interno della città è un programma elettorale molto gettonato, soprattutto nelle città piccole e medie, in sintonia con la macdonaldizzazione progressiva della passeggiata. La soppressione dei marciapiedi, infrastruttura igienica collegata allo smaltimento delle acque meteoriche, infrastruttura introdotta in Europa a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, produce due conseguenze. La prima riguarda la necessità di costruire sul nuovo tappeto calpestato ostacoli solidi per impedire ai camion di cozzare la mattina prima delle nove contro le insegne e le pensiline delle botteghe di lusso (vedi la rue de Bourg di Losanna). La seconda riguarda l’abbassamento o la cancellazione del livello orizzontale di riferimento che segnava l’alzato delle facciate. Basta una differenza di 10 centimetri per produrre un effetto visivo di mummificazione per non dire d’escoriazione (vedi il Graben di Vienna). Una terza conseguenza può sussistere nel fatto, generalmente voluto dai promotori urbani, che una gerarchia si stabilisce tra ambienti riqualificati e strada senza qualità. Lasciatemi rimpiangere le bellezze dell’asfalto. La perversione sublime si manifesta quando il Municipio di una piccola città, la cui pavimentazione pietrosa è invidiata da tutta la Svizzera, bandisce un piccolo concorso locale per tappezzare di nuovo la piazza e la strada centrale del mercato settimanale davanti alla chiesa principale, concorso demagogico senza esito (vedi Bellinzona all’inizio del Terzo Millennio).
Forse lo slogan elettorale della «zona pedonale» diventa programma urbano quando si combina alla nozione di «moderazione del traffico» che implica la complementarietà più che l’opposizione delle speci. Non è che l’uomo discende dalla scimmia, la scimmia dall’albero, e il pedone dall’automobile? Tolto il più bel manufatto del mobilier urbain, l’automobile, si cerca di rimediare all’horror vacui con lampade, panchine, alberi, fontane, sculture. Il nuovo paesaggio urbano può essere la vetrina del trasporto pubblico restaurato (vedi i tram di Grenoble o di Ginevra) tramite la ricostruzione di marciapiedi allargati. Per disegnare un progetto che non somiglia solo all’acquisto di un tappeto di lusso, ci vuole una correlazione tra l’architettura del suolo, nuova espressione delle infrastrutture inserite nel sottosuolo, ma anche il ripensamento politico della rete dei trasporti pubblici.
La qualità, ideale corporativo della FAS
In Svizzera, la parola d’ordine della qualità, punto di ritrovo del mestiere compiuto nelle regole dell’arte, coincide colla fondazione della Federazione degli Architetti Svizzeri nel 1908. Si proclama lo statuto della qualità architettonica. Essa si appoggia su tre criteri: a) il disegno della forma in quanto totalità, dall’insieme al dettaglio; b) un’esecuzione curata con precisione; e) l’espressione stilistica dell’identità nazionale. Da questi tre criteri, due sopravviveranno alla prima guerra mondiale, quando il concetto di stile entra in crisi. Per promuovere la qualità, la FAS stabilisce un doppio meccanismo. Il primo è la cooptazione. I membri sono scelti dai membri sulla base delle loro realizzazioni che costituiscono il solo herd book. Questo meccanismo, quando vecchie volpi invitano giovani lupi, assicura la continuità della specie. Il secondo meccanismo è la pubblicazione della parte saliente del catalogo FAS nella rivista che rappresenta la FAS. Questo effetto speculare conforta l’ideale confederale della qualità non solo all’interno del paese, ma traccia il ritratto dell’architettura in Svizzera davanti al «resto del mondo». Si esprime, si esporta l’immagine della «Svizzera che costruisce».
Oggi si sfoglia la rivista Werk, in esistenza continua dal 1914, e si scopre non solo il palmares dell’architettura moderna in Svizzera, ma anche il centro di gravità del dibattito teorico elvetico: Camille Martin, Hans Bernoulli, Hannes Meyer, Alfred Roth, Max Bill, Lucius Burckhardt, Bruno Reichlin, Martin Steinmann. È probabile che il trionfo della FAS, orgasmo qualitativo irripetibile sia stato I’EXPO del 1964 a Losanna. I politici radicali losannesi scelgono 1’ «architetto in capo» dopo una conversazione privata. L’architetto commenta la ricchezza e le bellezze paesaggistiche del paese «uno e diverso» (vecchio slogan già proposto all’esposizione nazionale di Zurigo nel 1939). Per distribuire il lavoro ai colleghi, l’architetto Alberto Camenzind traccia un piano direttore diviso in settori tematici: una margherita con tanti petali. La ripartizione confederale dei progetti corrisponde all’organizzazione regionale della FAS. Messe in concorrenza, le diverse sezioni propongono sistemi esperimentali che entrano in dialogo tra loro, prototipi che dovrebbero interessare un bel giorno l’industria dei materiali. Niente nella configurazione formale dei diversi padiglioni cerca di illustrare l’appartenenza campanilistica ad una regione che potrebbe chiamarsi Basilea, Ginevra, Romandia, Ticino, Grigioni, Zurigo. Così il ginevrino Saugey lavora con le tensostrutture del tedesco Frei Otto. Il bilancio tecnico è quello di un successo d’attenzione internazionale maggiore nel campo dell’ingegneria e dell’architettura. Mi chiedo a cosa serve oggi ricordare che I’EXPO losannese del 1964 segnò il trionfo internazionale della FAS. Storicamente, posso segnalare il successo dell’equazione fas qualità produzione elitaria. Posso anche constatare che la fas esiste ancora oggi per promuovere l’organizzazione corporativa della qualità tramite il meccanismo del concorso, del dibattito e della pubblicazione. Mi chiedo se, tra le stars dell’architettura «mondiale» ci sono «membri della fas». La risposta è affermativa, anche se queste stars preferiscono pensarsi come anti-stars. Quando si parla di stars, non si deve dimenticare che questi astri sono stati all’inizio architetti locali, capaci di vincere concorsi locali.
II tema della résistance
Nella stampa variopinta del Canton Ticino, l’argomentazione odierna dei partiti di destra e di sinistra in cerca d’elettorato consiste nel denunciare i progetti pubblici di qualità (gli unici progetti non clandestini e che fanno discutere) come se fossero «mausolei» destinati a commemorare nell’eternità la fama individuale di mostri sacri. Davanti all’architettura, il programma politico della destra, proteggere la sfera privata, rompere le scatole, si unisce a quello della sinistra, muovere l’equità delle chances. A me piace la critica e la necessaria messa in dubbio. Non è che il consenso della destra e della sinistra contro i «mausolei» e i «faraoni» lascia poco spazio alla discussione sulla qualità pubblica dell’architettura? La bocciatura del progetto raggruppa la maggioranza. Esempi d’alleanza democratica «contro natura» occorrono non solo nel Canton Ticino ma anche a Ginevra, e a Losanna. Mi viene in mente l’analisi di Michel Bassand, la sua dimostrazione che, da trent’anni, la struttura politica amministrativa della Svizzera rafforza una mitologia arcaica fondata sul mito gemello dell’autonomia comunale e cantonale. Questo mito rafforza il potere degli interessi privati la cui visione sorvola le frontiere. Si parla allegramente oggi in Ticino della «frontiera» tra Ascona e Locarno.
Allora si capisce che gli architetti interessati alla nozione di territorio e di metropoli resistono alla dominazione patriarcale della nostalgia acritica.
Luigi Snozzi propone il tema della résistance negli Anni 1980, come piattaforma del suo insegnamento al politecnico federale di Losanna. Non si tratta di uno slogan «sessantottardo» ma della convinzione che l’architettura deve forzare una situazione politica che preferisce lo status quo e la mediocrias. Non si rinuncia alla democrazia come luogo di compromesso. Al contrario, si pensa la polis come luogo del dibattito. Il progetto è polemica. Non può raggiungere il consenso. La città sarà riformata con l’energia dell’utopia. La polemica dell’architetto utilizza la rappresentazione grafica e plastica per nutrire la discussione e proporre il sogno realista di un futuro raggiungibile. Non è una posizione facile quella di Snozzi davanti ai politici e ai colleghi. Comporta una dose di rischio eroico. Il primo rischio è di mettersi fuori gioco. Persino quando Snozzi vince dei concorsi, vuoi per un ospedale, vuoi per un centro amministrativo cantonale, i progetti incontrano l’inerzia newtoniana dei medici che fanno il tifo per una clinica e per il «loro» ospedale, o dai difensori della popolazione del quartiere che sarebbe stato sacrificato alla costruzione d’uffici pubblici, anche se il concorso voleva in compenso la costruzione d’alloggi sociali. Concorsi vinti, progetti bocciati. Nei due casi la bocciatura di Snozzi si collega all’insuccesso politico di magistrati cantonali che sostenevano la necessità di nuovi progetti.
La résistance culturelle proclamata da Snozzi era parallela alla riflessione pessimista di Bernard Huet negli stessi anni. Huet opponeva la pianificazione (urbanisme) come gestione del fenomeno quantitativo alla pratica dell’architettura, indirizzata verso la provocazione del progetto. L’architettura lottava contro la città in una situazione di architecture contre la ville. Il paradosso si collocava nel fatto che gli stessi architetti moderni (protagonisti del «Movimento Moderno» dice Huet), partigiani dopo il 1945 del codice della città funzionale (Charte d’Athènes) erano responsabili di quest’incompatibilità. Il teorico francese bocciava una dopo l’altra le tendenze critiche sviluppate ulteriormente contro la città funzionale: in un primo tempo la teoria dell’adeguazione della morfologia architettonica alla tipologia urbana (Rossi, Aymonino), quando si cercava di collocare la rivendicazione dell’autonomia disciplinare all’interno della lunga durata della storia. Huet bocciava anche la politica della ville par projets, sperimentata in poche città progressiste, Barcellona, Berlino Ovest, quando le municipalità cercavano di insediare «pezzi» nuovi di città, progetti eccellenti, scelti da giurie eccellenti. In conseguenza non c’era neanche speranza nella pratica del «progetto contro il piano» e nella collezione di frammenti esemplari. Huet sembrava preferire la «risposta al contesto» e le sue realizzazioni future si sarebbero ancorate al contesto urbano di Parigi. Cosa rimaneva se non una situazione di pessimismo lucido, la retorica della tragedia: impossibilità del tutto, impossibilità delle parti per restaurare il tutto, effetto limitato della risposta al contesto?
Cosa abbiamo imparato nel frattempo? Oltre l’erosione del Welfare State, ovviamente legato alla degradazione dello spazio pubblico, siamo confrontati al quadro beuysiano dei «non luoghi» dipinti con amarezza da Auge, all’ironica passeggiata urbana woodyalleniana di Lucius Burckardt nelle periferie di Milano e di Bordeaux per scoprire il vero contesto dell’architettura, all’ottimismo avventuroso della «città generica» aeroportuale di Koolhas, globalizzazione della tipologia metropolitana, all’apologia galfettiana dei «grandi spazi» all’interno della città. Milioni di persone vivono nelle «baraccopoli» in Africa, in India, nell’America del Sur. La parola «baraccopoli» ormai fa parte dell’esistenza stessa della metropoli. Per non perdere ogni speranza, si tira avanti con la pianificazione regionale e gli scambi interdisciplinari. Soprattutto, si cerca di attivare il realismo critico e la sua sorella, la nostalgia critica. Lo sviluppo della «qualità pubblica» dell’architettura è frenato dalla difesa politica della sfera privata. La minoranza benestante compra il fuoristrada per girare in sicurezza colle scarpe lucidate.
I venti anni di Archi (1998-2018)
Per festeggiare il ventennale della rivista Archi, una selezione degli articoli più significativi è andata a costituire una timeline, tracciando una linea di continuità tra il 1998 e il 2018. Tutti gli articoli sono contenuti nel dossier «I venti anni di Archi (1998-2018)».