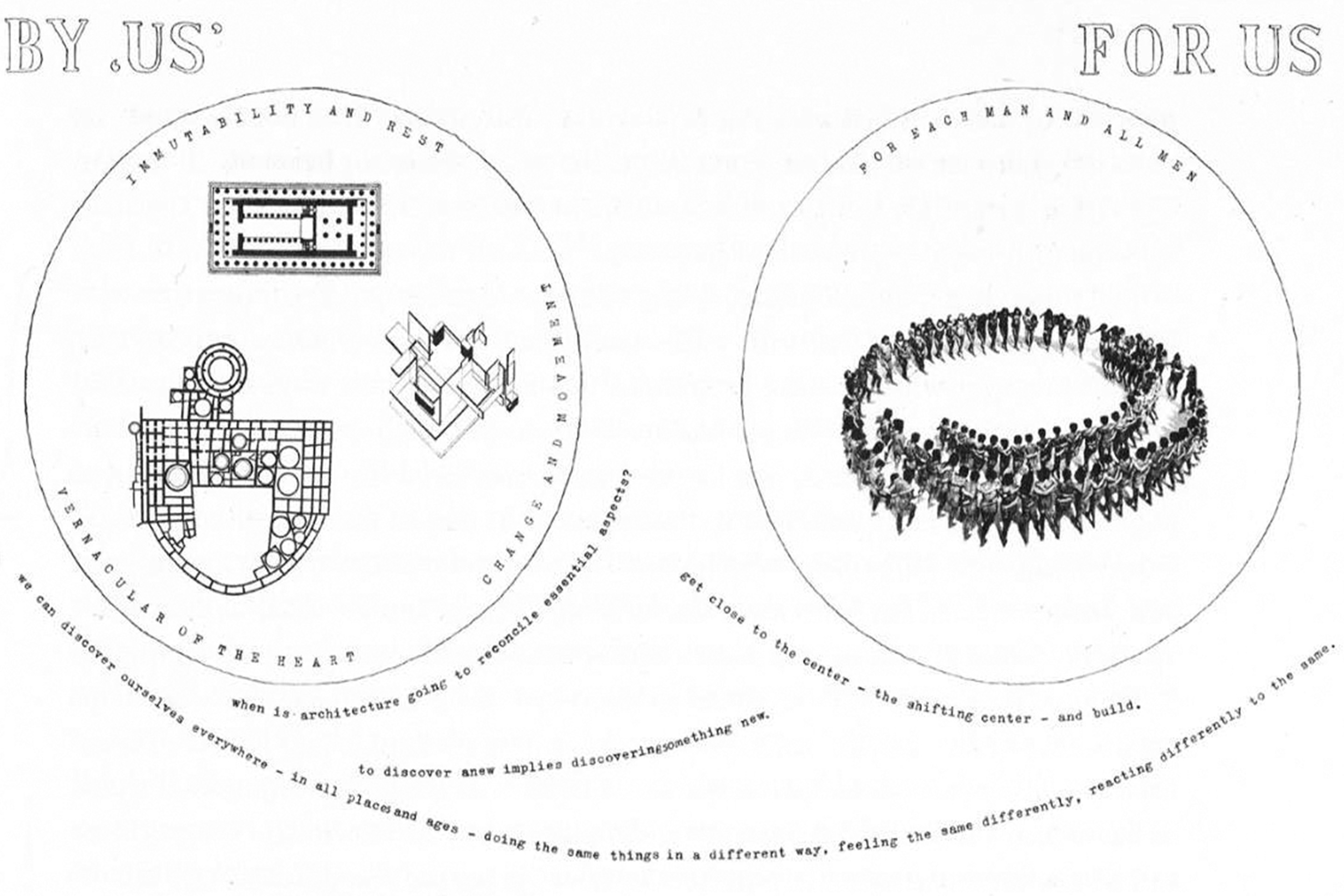La cura non è sentimento, è forma
La cura non è un gesto accessorio, ma un principio infrastrutturale che orienta architettura e urbanistica. Questo numero di Archi esplora come lo spazio costruito possa sostenere vulnerabilità e convivenza, trasformando fragilità in risorse per una vita collettiva più giusta.
Care is not a sentiment, it is a form english version
Non è un gesto occasionale di compassione, ma un principio strutturale che orienta il modo in cui progettiamo gli spazi, organizziamo i territori e abitiamo il mondo. In un’epoca segnata da precarietà sociale, invecchiamento della popolazione, spostamenti migratori ed erosione dei legami comunitari, la cura emerge non come un sentimento morale, ma come un imperativo architettonico e urbano.
Come ci ricorda la teorica politica Joan Tronto, «la cura è una pratica... non solo qualcosa che sentiamo, ma qualcosa che facciamo». Questo passaggio dal sentimento alla struttura ci impone di intendere la cura come parte integrante delle disposizioni materiali e spaziali che sostengono la vita quotidiana. Pensare alla cura oggi significa ripensare le infrastrutture della convivenza. Significa chiedersi in che modo l’architettura possa sostenere la vulnerabilità senza ridurla a pietà, in che modo la pianificazione possa favorire
l’incontro senza imporre il controllo e in che modo l’ambiente costruito possa diventare un veicolo di giustizia. In tal senso, la cura non è un semplice complemento al design funzionale, ma il suo fondamento stesso: una grammatica della costruzione basata sulla relazione, la continuità e la possibilità di rimanere. Resiste alla logica della velocità e dell’usa e getta. Interrompe il predominio dell’ottimizzazione e del contenimento. E afferma la dignità attraverso la scelta dei materiali, l’organizzazione spaziale e l’attenzione alle temporalità dell’abitare.
Questo numero di Archi affronta il tema della cura su più livelli, da quello domestico a quello territoriale, dallo spazio privato di un’abitazione alla vita collettiva del quartiere. Il saggio La dimensione domestica della cura (Luca Reale) apre la discussione mostrando come le forme di abitazione collettiva possano andare oltre la resilienza verso l’antifragilità: alloggi che crescono e si rafforzano affrontando la vulnerabilità e coltivando il sostegno reciproco. In questa cornice, la casa non è un’unità chiusa, ma una struttura porosa, capace di ospitare solidarietà intergenerazionali e nuove forme di convivenza. Due progetti esemplificano questo orizzonte: il
Dipartimento di psichiatria CHUV di Cery-Prilly, dove il design terapeutico integra la cura nelle routine spaziali, e la Casa anziani Malcantonese di Caslano, dove la domesticità stessa diventa un’architettura di continuità e sostegno.
Da qui, la riflessione si allarga alle condizioni dei rifugiati e al riconoscimento della garanzia di sostegno e dignità. Accoglienza e diritto all’assistenza (Hind Al-Shoubaki) ridefinisce l’accoglienza non come controllo ma come relazione, e l’assistenza non come carità ma come pratica spaziale. L’architettura dell’accoglienza è spesso caratterizzata da tensioni tra contenimento e ospitalità, tra efficienza e dignità. Tuttavia, progetti come gli edifici residenziali per rifugiati a Bubikon e il centro federale di asilo a Balerna-Novazzano dimostrano che è possibile un altro approccio. Qui l’architettura appare come un mezzo di ospitalità, che crea continuità, appartenenza e possibilità di integrazione anche all’interno dei vincoli della regolamentazione amministrativa. La questione non è solo come ospitare le persone sfollate, ma come creare le condizioni affinché l’atto dell’arrivo diventi l’inizio della partecipazione alla vita collettiva.
Infine, Niente e nessuno è di troppo (Matthias Drilling) si concentra sull’assistenza a livello di quartiere, dove la forma
urbana diventa una proposta etica e architettonica. Se Henri Lefebvre sosteneva che il diritto alla città fosse una richiesta di partecipazione e riconoscimento, il concetto di assistenza ci permette di reinterpretare questo diritto come un insieme di pratiche materiali e infrastrutture relazionali. In questo caso, la vicinanza crono-urbanistica, gli inviti simbolici e gli spazi di incontro non sono ideali astratti, ma condizioni pratiche per la giustizia spaziale. Due progetti illustrano questa traiettoria: il quartiere intergenerazionale di Parco San Rocco a Coldrerio, progettato come struttura condivisa per tutte le età, e la Casa per quasi tutto a Zurigo, dove la domesticità e l’appartenenza collettiva sono oggetto di una negoziazione dinamica. In entrambi i casi, la cura è spazializzata come pratica continua di apertura, adattabilità e responsabilità condivisa.
Nel loro insieme, queste riflessioni e questi progetti dimostrano che la cura non è una questione marginale, ma una questione centrale per l’architettura e l’urbanistica contemporanee. Non è un complemento soft alla progettazione tecnica, ma un principio infrastrutturale, un modo di concepire, costruire e abitare gli spazi che plasmano il nostro futuro comune. Mettendo in primo piano la cura, questo numero insiste sul fatto che l’architettura non riguarda solo la risoluzione dei problemi, né la sola sperimentazione estetica. Riguarda la costruzione delle condizioni per una vita dignitosa, interdipendente e sostenibile.