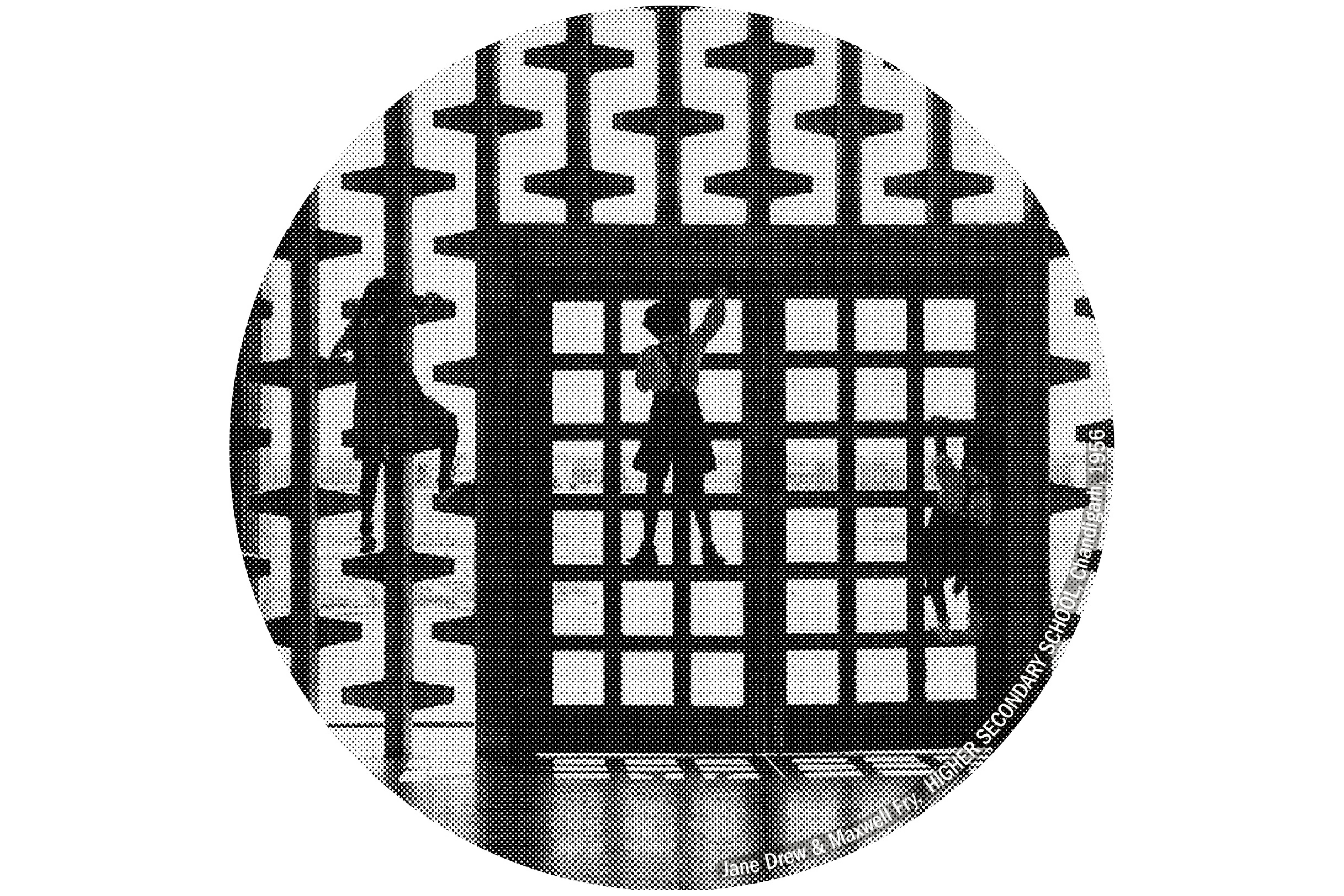Mettersi in gioco:
Fare un passo avanti significa immaginare il domani con cura: una pratica radicata nella memoria ma aperta al cambiamento, che intreccia voci, media e storie in un archivio vivente, trasformando fragilità in forza e costruendo una cultura della responsabilità.
stepping up english version
ipotizzando il domani
Prendersi cura è una forma di responsabilità che attraversa la vita quotidiana e lo spazio che abitiamo, conducendoci a guardarlo non solo in senso fisico, ma anche culturale: una rivista, come un progetto, è un luogo «costruito», in cui dimorano memorie, prospettive e voci che hanno tracciato geografie culturali e professionali. Riordinare le pagine del passato significa riconnettere frammenti di una storia lunga oltre un secolo – da Rivista Tecnica fino ad Archi – ritrovando il filo con territorio e comunità. Cura e spirito critico sono le fondamenta di una pratica editoriale tramandata con partecipazione.
Oggi il panorama dell’informazione ci pone di fronte a una certezza: la comunicazione non è più solo carta, ma intreccio di media e linguaggi. La scrittura dialoga con video, podcast e piattaforme digitali, generando letture transmediali, specchio di un «lettore» non più incasellabile. Il compito di Archi è tessere insieme questi formati in una trama coerente, capace di alternare velocità e riflessione, immediatezza e memoria. Nella rete dei media di espazium – Archi, Tec21 e Tracés, con i rispettivi siti trilingui – ogni elemento dialoga con gli altri, come stelle che si illuminano solo se unite da una costellazione. Espazium, come ogni buon progetto, si rafforza nella pluralità e nell’apertura alla cultura del costruire.
Da inizio anno la redazione ha dato prova di grande dinamicità, con articoli, videointerviste e post che hanno documentato la Biennale di Venezia, i concorsi in Ticino e oltre, seguendo l’attualità con attenzione al territorio e alle vicende dei professionisti svizzeri. Abbiamo ampliato la nostra presenza sui social – cercate espazium.ch su Instagram, Facebook e LinkedIn – e alimentiamo le sezioni del sito con contributi in inglese, francese e tedesco. Vogliamo dar corpo alla cultura della Svizzera italiana, trasformando ogni contenuto in un gesto di cura verso il presente e il futuro.
Il cambiamento che ci attende non è un esercizio di stile, ma un atto di responsabilità verso il patrimonio affidatoci: un archivio vivente di risorse, persone e storie. Con il nuovo dossier online Fondamenta riallacceremo i fili col passato, riportando alla luce gli articoli più emblematici che hanno segnato il percorso delle riviste della SIA Ticino. È il nostro modo di guardare avanti senza dimenticare ciò che ci ha formati. Il 2026 sarà un anno di transizione, aspettative e innovazioni. Non un «cambiare tutto perché nulla cambi», ma un percorso consapevole, una navigazione che accetta la tempesta senza temerla. Insieme ai lettori, apriremo il sipario su un nuovo capitolo: una rivista rinnovata, attenta e critica, che continua a prendersi cura della cultura del progetto e della costruzione.
partecipando con impegno
La cura si manifesta nelle scelte che danno forma al nostro «abitare»: sono proprio le fragilità – dell’età, della salute, delle condizioni sociali o delle appartenenze culturali – a rivelarsi non come eccezioni, ma come condizioni condivise che ci definiscono. In questo orizzonte l’architettura si rivela un atto etico: ogni progetto diventa dispositivo capace di includere o escludere, di proteggere o marginalizzare. La geografia che costruiamo non è mai neutra. È, per riprendere Liz Ogbu, «una geografia della giustizia»: non un auspicio, ma una responsabilità concreta che riconosce l’accesso equo alle risorse come un diritto fondamentale e non come un privilegio.
Yona Friedman, architetto e visionario, nato a Budapest nel 1923, visse in prima persona la precarietà dell’essere sfollato, la vulnerabilità di chi deve reinventarsi un luogo in cui sopravvivere. La sua esperienza di guerra, di prigionia e di migrazione segnò in profondità la sua idea di architettura. Non come gesto monumentale o come esercizio di stile, ma come strumento per agire contro l’apatia: inventare, ibridare, condurre l’utopia dentro il reale. Con la sua «architettura mobile» mostrò che lo spazio deve restare aperto all’interpretazione, pronto ad accogliere i cambiamenti della vita e le esigenze di comunità in continuo mutamento. Un monito e un invito a riconoscere che la precarietà e la violenza che lui visse si ripetono oggi, come privi di memoria: invochiamo allora quella trama leggera, aerea e sognante, a ricucire l’imponderabile.
Se Friedman ci mostra come precarietà e vulnerabilità possano guidare l’invenzione architettonica, altre pratiche, in contesti diversi, hanno cercato di tradurre principi simili in progetti concreti, dimostrando che l’attenzione alla fragilità e alla comunità attraversa trasversalmente la storia dell’architettura. Carla Tagliaferri, architetta italiana attiva dagli anni Sessanta, ha rivolto la propria ricerca verso un’architettura attenta alla dimensione sociale e ambientale: dai progetti di edilizia popolare all’ideazione di spazi pubblici e paesaggi urbani, la cura non si riduce a servizio, ma diventa un orizzonte di inclusione e qualità condivisa dello spazio.
Nei percorsi che colleghiamo, nelle soglie che attraversiamo, nei servizi che utilizziamo, si misura la capacità dello spazio di accogliere e sostenere chi lo abita. Le tracce lasciate dalla buona progettazione diventano impalcatura su cui si innesta una geografia etica più ampia, in cui la fragilità non viene occultata ma sostenuta. Ciò che inizia come cura concreta nei progetti si traduce così in una responsabilità estesa, capace di orientare lo spazio verso equità e inclusione.
In questa prospettiva, il prendersi cura del bene comune somiglia al gesto del kintsugi: una riparazione che non nasconde le fratture ma le riconnette, trasformandole in segni di forza e di bellezza. Anche i nostri spazi, quando accolgono fragilità e diversità, diventano cicatrici dorate che raccontano una nuova forma compiuta, più resistente e più piena.