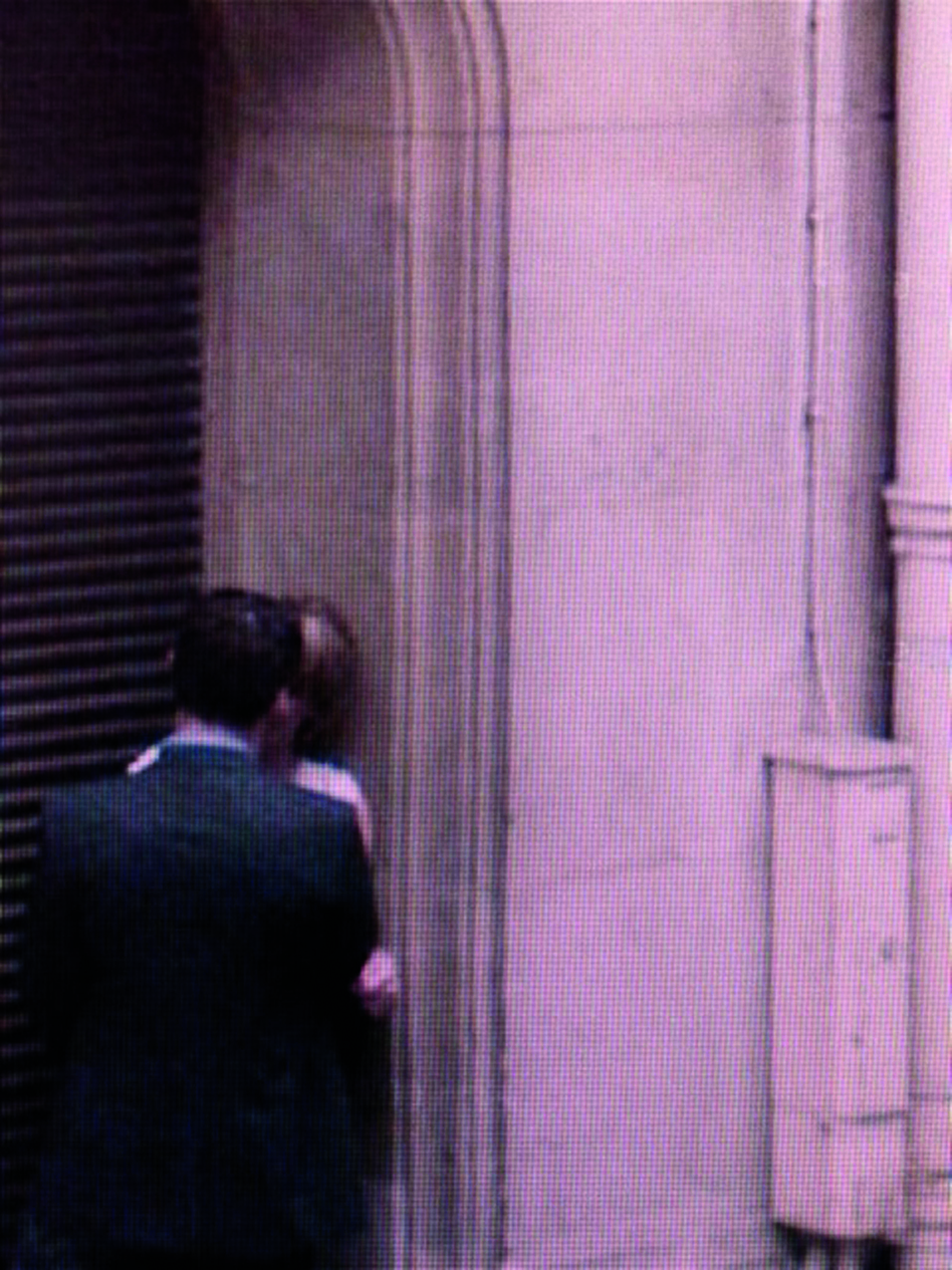Come anticipato dal titolo Borderlines. Città divise/Città plurali, la decima Biennale dell’immagine, svoltasi in Ticino con centro nevralgico a Chiasso nell’autunno 2017, ha indagato tramite numerose mostre le interrelazioni tra limiti, fotografia e città.
Che i limiti plasmino la città era già evidente per gli antichi romani, per i quali la fondazione dell’urbe coincideva con l’atto di tracciarne i confini. Oggi il rapporto tra città e limite si è fatto forse più astratto, ma leggi, convenzioni, confini di proprietà continuano a tessere una rete di limiti entro cui si articola la vita urbana. Per riflettere su tali dinamiche, la fotografia è un filtro particolarmente adatto: i limiti sono infatti costitutivi di questo medium, la cui invenzione rese possibile qualcosa di inaudito: ritagliare (delimitare) segmenti del reale. Ne sarebbe derivato un nuovo approccio all’atto creativo di cui si sarebbero fatte bandiera le avanguardie novecentesche – un approccio che aveva nell’obiettivo della macchina fotografica il suo modello. Esso si fondava sull’idea che l’essenza dell’arte non risiedesse nell’opera compiuta, ma nel gesto tramite cui l’autore sceglie cosa rappresentare. Questo gesto è innanzitutto atto di delimitazione: cosa rappresento, cosa non rappresento?
Queste e altre interrelazioni tra limite, città e fotografia vengono esplorate nelle opere del tedesco Michael Wolf, presentate allo Spazio Officina di Chiasso nell’ambito della mostra Life in Cities, a cura di Wim van Sinderen e degli organizzatori della Biennale (cornice dell’esposizione). Immortalando diverse città, Wolf si pone in dialogo con la loro (il)limitatezza, facendo al contempo della sua ricerca urbana un pretesto per esplorare le funzioni dei limiti nel processo di rappresentazione.
Wolf era stato allievo di Otto Steinert (1915-1978), autore che con la fotografia sperimentò incessantemente, tentando di dimostrare che essa non è, come si credeva ancora nel primo Novecento, un mero strumento tecnico tramite cui riprodurre la realtà, ma una forma d’arte autonoma. Lo fece con scatti pirotecnici, all’insegna di giochi di luce, sdoppiamenti ed effetti che portano il medium lontano da una semplice documentazione del visibile. Se si esamina il reportage con cui il giovane Wolf si laureò nel 1976, non si direbbe che gli esperimenti del maestro l’avessero influenzato: gli scatti realizzati a Bottrop-Ebel, d’un rigoroso bianco e nero, vogliono innanzitutto descrivere, con piglio quasi antropologico, la vita nella cittadina mineraria (salvo qualche cedimento al fascino del bizzarro: il casco di capelli platino di un’operaia…). Una maggiore vicinanza a Steinert e alle avanguardie si riscontra nelle altre serie in mostra, tutte realizzate dopo che Wolf, nel 2003, lasciò il suo lavoro di reporter per «Stern» e si dedicò alle proprie ricerche.
In Paris Street View, ad esempio, si confronta con la componente meccanica della fotografia, che costituì a lungo un argomento decisivo nelle mani di coloro che le negavano lo statuto di arte. Qui Wolf «aggiorna» la questione al terzo millennio, riflettendo sulle trasformazioni occorse. Una domanda fa da premessa alla serie: come si può raccontare per immagini Parigi senza farsi influenzare dal suo oneroso passato fotografico? Wolf risponde deponendo la fotocamera e affidandosi a… Street View. Dalla fluida unità di scatti automatici che vi riproducono Parigi, vengono scelte piccole scene (il balzo d’un cervo, una persona che orina, un bacio…), poi ingrandite fino a far risaltare la grana dei pixel e stampate in grande formato. L’atto di delimitare è così posto a fondamento dell’arte: ciò che l’occhio meccanico della fotocamera di Google ha registrato casualmente diventa opera dal momento che qualcuno vi seleziona un elemento, dichiarandolo rilevante. Sembra di sentir riecheggiare le parole con cui Duchamp, nel 1917, difese la sua opera Fontana, ready-made fatto di un orinatoio rovesciato (e firmato): «[che l’artista] abbia fatto o no la fontana con le sue mani non ha importanza. Egli l’ha SCELTA». Pare tra l’altro che non sarebbe stato Wolf a selezionare le immagini, ma degli anonimi viandanti della rete: insomma, siamo di fronte a un vero e proprio ready-made fotografico.
Vi è poi un altro paradosso che spiazza l’osservatore di Paris Street View: mentre si contempla l’immagine sgranata di due amanti stretti in un coin, alla mente affiorano i baci di Doisneau… Se davvero Wolf ha abbandonato i panni di «street photographer» a favore di quelli di «Street View photographer» allo scopo di svincolarsi dall’immagine classica di Parigi, ha subito qui un’ironica sconfitta.
Con Architecture of Density – Hong Kong il dialogo tra limiti della città e limiti della fotografia si fa ancor più serrato. Come dichiara il titolo, tema della serie è la densità di una megalopoli che, per carenza di spazio, raggruma i suoi abitanti in una foresta di fitti grattacieli. Per raccontare la città sovrappopolata, Wolf mette a frutto i limiti imposti dall’obiettivo della macchina fotografica: «uso i blocchi di grattacieli per eliminare la linea del cielo e dell’orizzonte, appiattire ogni immagine e trasformare queste facciate in astrazioni apparentemente interminabili».1 L’effetto è un brulicante condensato di vita urbana senza spazi, senza respiro, senza fine, dove eserciti di finestre tutte uguali tracciano geometrie di concerto con i colori pastello dei palazzi. Dato che la muraglia di edifici si prolunga, senza vuoti né punti di fuga, oltre i margini dell’inquadratura, chi guarda è invitato a immaginare tutta Hong Kong come un’interminabile parata di muri.
A Chiasso le fotografie della serie erano presentate su vasti pannelli che fluttuavano sospesi, così che si poteva osservarle da lontano, lasciandosi annichilire dall’immane panorama di cemento, o da pochi centimetri di distanza: e qui si era sorpresi, perché la risoluzione delle immagini è tale che dietro ciascuna delle centinaia di finestre si scorgono tracce umane (un vaso, un peluche, biancheria…). S’instaura così una tensione tra la scala colossale della vita urbana e le individualità minute che vi trovano espressione; da questo equilibrio la serie trae la sua imponenza. Si capisce allora perché, pur di raggiungere tale risultato, il fotografo abbia forzato un po’ il reale: se avrete, come me, la fortuna di scrutare queste immagini in compagnia di un’acuta osservatrice, vi sarà forse fatto notare che, talvolta, tra le miriadi di finestre se ne scorgono due accomunate da somiglianze davvero sconcertanti (occhio alla macchia!). «L’arte è una menzogna che avvicina alla verità», avrebbe commentato Picasso; e d’altra parte anche Steinert credeva nell’«incoraggiare ogni genere di iniziativa creativa che contribuisca attivamente a produrre un’immagine fotografica elaborata e attuale e che stimoli una reale sensibilizzazione alla qualità fotografica dell’immagine».2
Mentre nella serie dedicata a Hong Kong i limiti della fotografia fanno risaltare l’illimitatezza della città, in The Transparent City – Chicago non è la vastità a essere messa a fuoco: «scattando da tetti pubblici nel corso di molti mesi, ho adottato un approccio visuale simile al mio lavoro architettonico a Hong Kong. Però la trasparenza e la dimensione monumentale degli edifici di Chicago ha dato un risultato molto diverso: la città è molto meno densa di Hong Kong, creando così un più grande senso di profondità delle immagini, mentre la trasparenza dei suoi grattacieli di vetro porta la vita all’interno a trapelare fuori».3 In effetti, mentre nelle fotografie di Hong Kong le presenze umane tendevano a restare celate nell’oscurità degli interni, gli scatti statunitensi permettono di cogliere gli intimi movimenti delle persone nei palazzi. A volte addirittura Wolf trae dalle sue vaste panoramiche ingrandimenti di volti, spesso colti in momenti di scoramento; di essi fa dei quadretti autonomi, esposti a fianco dell’immagine da cui sono tratti. Il voyeurismo che pervade la serie viene giocosamente tematizzato in una fotografia dove, in uno degli appartamenti illuminati, si scorge una tv che trasmette La finestra sul cortile, con James Stewart che spia i vicini con la sua macchina fotografica.
Sebbene Wolf asserisca di essersi approcciato a Hong Kong e Chicago in modo simile, guardando le immagini ci si accorge che le due città appaiono radicalmente diverse innanzitutto per sue specifiche scelte riguardanti, ancora una volta, il processo di delimitazione. Se gli scatti di Hong Kong colgono frontalmente la città inquadrando volutamente solo edifici, quelli di Chicago tendono a riprenderla dall’alto, catturando anche il cielo e mostrando così il dispiegarsi in prospettiva dei palazzi. Se gli scatti di Hong Kong sono realizzati di giorno, così da mettere in risalto gli esterni assolati, per Chicago si prediligono le vedute notturne, con le lampade accese che enfatizzano la trasparenza dei grattacieli e fanno rilucere gli interni a uso e consumo del fotografo-voyeur. Se, allora, Chicago e Hong Kong sembrano, esaminate queste serie, nettamente diverse, ciò dipende innanzitutto dalle modalità con cui l’autore le ha raccontate, e solo secondariamente da differenze effettive. Ma cosa guida Wolf nella scelta di tali modalità? A confrontare le serie, si nota che il suo approccio cambia in modo sostanziale se il luogo rappresentato si trova in Oriente o Occidente.
I concetti di studium e punctum, proposti da Roland Barthes nel descrivere l’immagine fotografica,4 aiutano a cogliere la radice di questa differenza. Il punctum è ciò che «partendo dalla scena, come una freccia, mi trafigge»; è l’elemento che cattura l’attenzione a sorpresa, irrazionalmente; per esempio la macchina fotografica che, in una veduta di Chicago, mi guarda dallo schermo di un televisore. Lo studium è invece il «campo» della fotografia: l’insieme che colgo razionalmente e che mi fornisce una certa informazione, appoggiandosi sulle mie conoscenze; per esempio, sempre nella veduta di Chicago, vedo delle persone; ciascuna è davanti a uno schermo, in un appartamento, sola; posso dedurre che l’autore mi voglia parlare della solitudine nella metropoli.
Ecco, si potrebbe dire che, quando fotografa la città occidentale, Wolf va in cerca del punctum: delimitando una porzione di immagine, come fa in Paris Street View e negli ingrandimenti di The Transparent City, mette in evidenza proprio ciò che l’ha «trafitto». Si focalizza così su un singolo gesto, su un singolo personaggio; sono immagini che raccontano una storia con uno specifico eroe. Quando fotografa le città orientali, invece, tutto si fa studium: l’occhio non è sospinto verso un dettaglio che «punge», tutto qui ha lo stesso peso, lo stesso valore; non c’è un elemento che spicca nell’insieme, non c’è eroe o racconto: la dimensione narrativa svanisce, sostituita da un invito alla contemplazione del tutto. Così il «saggio Zen», nelle parole di Umberto Eco, «contempla beato le libere possibilità del mondo circostante, il gioco delle nuvole, i riflessi nell’acqua, le trame sul terreno».5 Le città diventano allora (e chissà se Wolf l’aveva previsto!) emblemi di due visioni dell’arte: l’arte come delimitazione di ciò che è notevole, l’arte come sconfinamento nel tutto.
Note
- In the Life of Cities, a cura di Mohsen Mostafavi, Lars Müller Publishers, Zurigo 2012, p. 292.
- Citato in Fotografia del XX secolo – Museum Ludwig Colonia, Taschen, Colonia 2007, pp. 666-667.
- In the Life of Cities, a cura di Mohsen Mostafavi, Lars Müller Publishers, Zurigo 2012, p. 180.
- Roland Barthes, La camera chiara – Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 1980; le citazioni provengono rispettivamente da p. 28 e 27.
- Umberto Eco, Opera aperta, Bompiani, Milano 1962, p. 177.